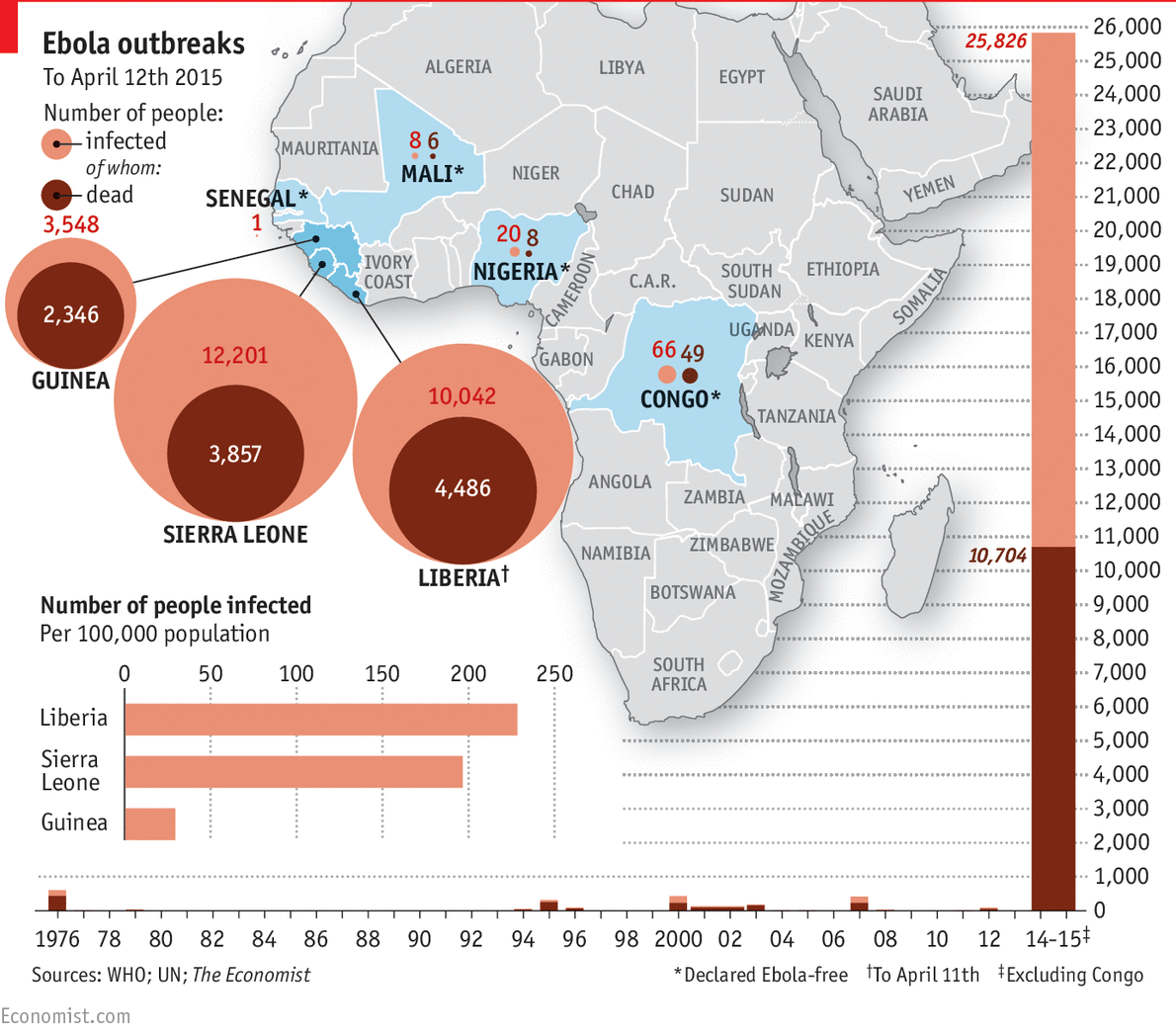La tubercolosi colpisce oggi oltre 12 milioni di persone nel mondo (vedi QUI). Le previsioni per il prossimo futuro, nonostante il calo registrato negli ultimi anni nei paesi sviluppati, non sono positive.
Se la vaccinazione prima e la scoperta degli antibiotici poi avevano fatto sperare in un futuro in cui la tubercolosi sarebbe diventata non solo una malattia rara ma un problema del passato, la diffusione sempre maggiore di ceppi batterici multi-resistenti ha riproposto il problema facendo spostare indietro di anni le "lancette terapeutiche".
Il trattamento ad oggi usato per i casi più resistenti, una combinazione di quattro farmaci diversi, non solo non è più garanzia di successo ma si è mostrata labile di fronte alla sfida di ceppi batterici sempre più agguerriti.
Ad alimentare il problema dei ceppi multi-resistenti le condizioni di sovraffollamento delle megalopoli dei paesi in via di sviluppo e il nuovo fenomeno della tubercolosi come malattia di importazione, conseguente ai movimenti migratori incontrollati verso l'Europa (articolo precedente, QUI)
Se la vaccinazione prima e la scoperta degli antibiotici poi avevano fatto sperare in un futuro in cui la tubercolosi sarebbe diventata non solo una malattia rara ma un problema del passato, la diffusione sempre maggiore di ceppi batterici multi-resistenti ha riproposto il problema facendo spostare indietro di anni le "lancette terapeutiche".
Il trattamento ad oggi usato per i casi più resistenti, una combinazione di quattro farmaci diversi, non solo non è più garanzia di successo ma si è mostrata labile di fronte alla sfida di ceppi batterici sempre più agguerriti.
Ad alimentare il problema dei ceppi multi-resistenti le condizioni di sovraffollamento delle megalopoli dei paesi in via di sviluppo e il nuovo fenomeno della tubercolosi come malattia di importazione, conseguente ai movimenti migratori incontrollati verso l'Europa (articolo precedente, QUI)
 |
| M. tubercolosis (CDC/Elizabeth White) |
Ma tralasciamo per il momento il discorso centrato sulla resistenza agli antibiotici, di cui ho ampiamente discusso in passato (QUI), e concentriamoci su un aspetto non meno problematico cioè le recidive di cui soffrono molti pazienti dopo aver completato il trattamento ed essere "apparentemente" guariti.
Alcuni studi recenti hanno indagato le modalità con le quali il Mycobacterium tuberculosis (il batterio responsabile della tubercolosi) elude un trattamento di per sé efficace. Sembra infatti che in presenza di un ambiente sfavorevole il batterio si trasformi in una sorta di "zombie" all'interno del corpo del paziente. Nulla a che vedere con comportamenti narrati da George Romero però; si tratta di un termine scelto dai ricercatori per indicare un batterio che si pone in una condizione di quasi totale inattività metabolica "vigile e reversibile", in grado cioè di riattivarsi una volta che il pericolo sarà venuto meno.
Nota. I ricercatori hanno volutamente usato l'ambiguo termine "zombie" invece del classico "spore", cioè le classiche forme inerti tipiche di alcuni batteri Gram positivi (come avviene in Streptomyces, Bacillus e Clostridium), anch'esse indotte in risposta a condizioni ambientali inadatte per la vita batterica (temperatura, carenza di nutrienti o di acqua, etc). Le spore rappresentano una sorta di scialuppa di salvataggio creata e liberata dalla cellula in lisi sotto forma di endospora. Questa contiene difatti tutti i codici necessari per tornare attiva e vitale ma è metabolicamente inattiva (uno stato definito come criptobiotico).
Nel caso della tubercolosi il batterio fa qualcosa di diverso dal diventare una spora quando l'ambiente diventa "pericoloso": assume una forma non propriamente vitale dato che non si divide ma a differenza della spora mantiene attiva la produzione di energia e la sintesi proteica. In pratica evita di dirigere il suo metabolismo verso la via che porta alla crescita cellulare prima e a cascata alla divisione cellulare.
Proprio la possibilità delle cellule di entrare nello stato "zombie", definito tecnicamente come NGMA (acronimo per "non cresce ma ha metabolismo"), sarebbe la causa principale delle recidive della malattia in pazienti apparentemente curati per la TBC.
Quale è il segnale che dice al batterio "pericolo imminente. Mettersi in sicurezza"? Una qualunque condizione di pericolo immediato come un trattamento antibiotico aggressivo.
Per quale motivo si scopre solo ora l'esistenza di questo stato metabolico nel micobatterio?
La difficoltà era intrinseca al problema, dato che la caratterizzazione di un batterio si basa in primis sulla sua capacità di proliferare (un problema importante in microbiologia quando bisogna isolare una specie che ha bisogno per crescere di condizioni molto particolari). Se il batterio non cresce, non puoi isolare la colonia e quindi non puoi identificare il batterio.
L'elemento chiave che ha permesso di identificare questa peculiarità batterica è stato lo scoprire che alcuni dei batteri apparentemente uccisi dal trattamento antibiotico erano in realtà metabolicamente attivi: quindi per definizione queste cellule non erano né morte né spore, e tantomeno in stato stazionario.
Forti di tale osservazione i ricercatori del EPFL (Politecnico Federale di Losanna) hanno pensato bene di modificare geneticamente i batteri in modo tale da renderli in grado di produrre una proteina fluorescente, la presenza della quale poteva essere utilizzata come marcatore di attività trascrizionale dei geni e quindi segnalatore di metabolismo. Ottenuto il batterio modificato diventava un giochetto seguire al microscopio a fluorescenza il comportamento dei batteri cresciuti in diverse condizioni di stress (carenza di nutrienti, presenza di antibiotici o condizioni che simulassero l'attacco da parte del sistema immunitario del paziente).
Si è così ottenuta la prova che il Mycobacterium tuberculosis risponde alle condizioni di stress diversificando la sua popolazione in modo da massimizzare le possibilità di sopravvivenza. Uno degli esiti della diversificazione è la comparsa di cellule nello stato zombie (NGMA).
Il fenomeno è stato confermato in vivo: si è infatti osservato che i polmoni dei topi malati di tubercolosi sono particolarmente ricchi di queste cellule.
Ma il dato più interessante è che queste cellule sono paradossalmente meno abbondanti nei topi con sistema immunitario inefficiente. Il che a ruota indica che è proprio il sistema immunitario a giocare involontariamente un ruolo negativo chiave agendo come fattore "stressogeno" per indurre i batteri a "rintanarsi" nello stato NGMA.
Una volta che il batterio è "zombificato", l'azione degli antibiotici perde notevolmente di efficacia essendo queste molecole generalmente attive sulle cellule proliferanti e in ogni caso dotate di una discreta attività metabolica.
Questo spiegherebbe le recidive al termine del trattamento e, a lungo, andare anche la comparsa di ceppi resistenti agli antibiotici.
Un compito non semplice. Ma almeno oggi sappiamo in che direzione muoverci.
Fonte
- Stress and Host Immunity Amplify Mycobacterium tuberculosis Phenotypic Heterogeneity and Induce Nongrowing Metabolically Active Forms
Manina G, et al, Cell Host & Microbe (2015)
Consiglio vivamente la lettura dell'articolo di Heidi Arjes (Current Biology, 2014, 24(18): 2149-2155) se volete maggiori informazioni sulle cellule zombie.
Il lavoro di questa giovane e brillante ricercatrice dell'università di St. Louis, si è focalizzato sulle condizioni di stress che portano la cellula (Staphylococcus aureus) verso il punto definito di "non ritorno".
Il video di seguito ne riassume i concetti principali.
Se invece il vostro interesse è più verso il gore o atmosfere orrorifiche in biologia, allora vi consiglio la lettura di articoli precedenti: "Formiche zombie"; "La larva di vespa nasce come Alien"; "Ci sono cellule vive in cadaveri?"
Proprio la possibilità delle cellule di entrare nello stato "zombie", definito tecnicamente come NGMA (acronimo per "non cresce ma ha metabolismo"), sarebbe la causa principale delle recidive della malattia in pazienti apparentemente curati per la TBC.
Quale è il segnale che dice al batterio "pericolo imminente. Mettersi in sicurezza"? Una qualunque condizione di pericolo immediato come un trattamento antibiotico aggressivo.
Per quale motivo si scopre solo ora l'esistenza di questo stato metabolico nel micobatterio?
La difficoltà era intrinseca al problema, dato che la caratterizzazione di un batterio si basa in primis sulla sua capacità di proliferare (un problema importante in microbiologia quando bisogna isolare una specie che ha bisogno per crescere di condizioni molto particolari). Se il batterio non cresce, non puoi isolare la colonia e quindi non puoi identificare il batterio.
L'elemento chiave che ha permesso di identificare questa peculiarità batterica è stato lo scoprire che alcuni dei batteri apparentemente uccisi dal trattamento antibiotico erano in realtà metabolicamente attivi: quindi per definizione queste cellule non erano né morte né spore, e tantomeno in stato stazionario.
Forti di tale osservazione i ricercatori del EPFL (Politecnico Federale di Losanna) hanno pensato bene di modificare geneticamente i batteri in modo tale da renderli in grado di produrre una proteina fluorescente, la presenza della quale poteva essere utilizzata come marcatore di attività trascrizionale dei geni e quindi segnalatore di metabolismo. Ottenuto il batterio modificato diventava un giochetto seguire al microscopio a fluorescenza il comportamento dei batteri cresciuti in diverse condizioni di stress (carenza di nutrienti, presenza di antibiotici o condizioni che simulassero l'attacco da parte del sistema immunitario del paziente).
Si è così ottenuta la prova che il Mycobacterium tuberculosis risponde alle condizioni di stress diversificando la sua popolazione in modo da massimizzare le possibilità di sopravvivenza. Uno degli esiti della diversificazione è la comparsa di cellule nello stato zombie (NGMA).
Il fenomeno è stato confermato in vivo: si è infatti osservato che i polmoni dei topi malati di tubercolosi sono particolarmente ricchi di queste cellule.
Ma il dato più interessante è che queste cellule sono paradossalmente meno abbondanti nei topi con sistema immunitario inefficiente. Il che a ruota indica che è proprio il sistema immunitario a giocare involontariamente un ruolo negativo chiave agendo come fattore "stressogeno" per indurre i batteri a "rintanarsi" nello stato NGMA.
Una volta che il batterio è "zombificato", l'azione degli antibiotici perde notevolmente di efficacia essendo queste molecole generalmente attive sulle cellule proliferanti e in ogni caso dotate di una discreta attività metabolica.
Questo spiegherebbe le recidive al termine del trattamento e, a lungo, andare anche la comparsa di ceppi resistenti agli antibiotici.
Il problema non è poi così diverso da quello che è necessario fronteggiare per sviluppare una terapia efficiente e duratura contro l'HIV. Fintanto che il virus rimane silente, integrato nel genoma dei linfociti, i farmaci hanno probabilità nulla di portare alla eradicazione della malattia. Solo rimuovendo il fattore di selezione negativa alla proliferazione (fornito dal cocktail di farmaci anti-retrovirali), il virus riprende a dividersi ridivenendo così sensibile al trattamento. Ma se si rimuove il selettore negativo, il virus riprende a dividersi e si torna al punto iniziale. Non necessariamente. Se il virus viene ingannato forzandolo a replicarsi ma mantenendo nel contempo il trattamento farmacologico, allora si può sperare di eradicarlo dai suoi santuari. Tale approccio è portato avanti da alcune linee di ricerca, ovviamente ancora in fase sperimentale.E' verosimile che il futuro prossimo della ricerca sulla tubercolosi si focalizzerà su trattamenti mirati contro le cellule "zombie" sfruttando delle particolarità metaboliche della cellula o forzando la stessa ad uscire dallo stato NGMA (ridivenendo così sensibili ai trattamenti standard).
Un compito non semplice. Ma almeno oggi sappiamo in che direzione muoverci.
Fonte
- Stress and Host Immunity Amplify Mycobacterium tuberculosis Phenotypic Heterogeneity and Induce Nongrowing Metabolically Active Forms
Manina G, et al, Cell Host & Microbe (2015)
****
Consiglio vivamente la lettura dell'articolo di Heidi Arjes (Current Biology, 2014, 24(18): 2149-2155) se volete maggiori informazioni sulle cellule zombie.
Il lavoro di questa giovane e brillante ricercatrice dell'università di St. Louis, si è focalizzato sulle condizioni di stress che portano la cellula (Staphylococcus aureus) verso il punto definito di "non ritorno".
Il video di seguito ne riassume i concetti principali.
Se invece il vostro interesse è più verso il gore o atmosfere orrorifiche in biologia, allora vi consiglio la lettura di articoli precedenti: "Formiche zombie"; "La larva di vespa nasce come Alien"; "Ci sono cellule vive in cadaveri?"