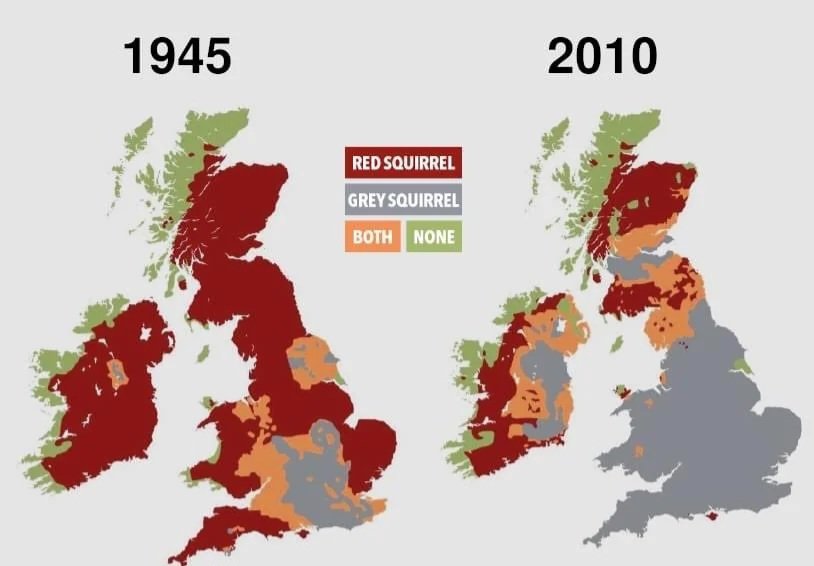Come i serpenti siano diventati tali (a partire da un vertebrato con zampe) è ancora frutto di ipotesi. Non tanto riguardo all'effettiva realtà di questa evoluzione (reperti fossili sono noti) ma sulle mutazioni che hanno reso possibile la regressione degli arti fino a farli scomparire del tutto o all'essere evidenti solo dopo accurata analisi (boa e pitoni hanno arti vestigiali)
A fare luce sulla questione arriva ora un ampio studio con l'analisi genetica (e comparativa) tra 14 specie di serpenti (appartenenti a 12 famiglie) confrontati poi con i dati di altre 11 specie precedentemente analizzate. Un campione scelto accuratamente in modo da abbracciare 150 milioni di anni della loro evoluzione
Lo studio è stato pubblicato lo scorso anno su Cell.
L'analisi ha evidenziato una alterazione comune a tutte le specie del gene PTCH1, coinvolto nello sviluppo degli arti. La prova del nove è stata quella di introdurre lo stesso tipo di mutazioni nell’equivalente murino di quel gene. Il risultato sono stati topi cone le ossa delle zampe molto più corte.
Tra i dati emersi anche le possibili (con)cause della bassa capacità visiva e la riprogrammazione degli organi uditivi dei serpenti innescata verosimilmente dalla vita sotterranea dei serpenti primitivi (in un modo dominato dai dinosauri). In questo caso si è tratto di mutazioni che hanno diminuito (o spento) l'attività di alcuni geni. Ad esempio la diminuita attività dei geni associati alla capacità di sentire le alte frequenze potrebbe aver portato alla riconfigurazione delle ossa dell’orecchio dei rettili, rendendoli molto più sensibili alle vibrazioni.
Ultima (si fa per dire data la mole del lavoro svolto) scoperta riguarda le mutazioni dei geni DNAH11 e FOXJ1, coinvolti nello sviluppo simmetrico dell'embrione, che spiegano la netta riduzione volumetrica (o anche scomparsa) del loro polmone sinistro
Il lavoro rappresenta un passo avanti non solo verso l’identificazione dei geni chiave nello sviluppo dei serpenti, ma anche verso l’individuazione di come lo sviluppo modella altri vertebrati, compresi gli esseri umani, e quindi l’identificazione di ciò che potrebbe andare storto e causare malattie o malformazioni.
In calce un articolo pubblicato nel 2015 sull'antenato "zampato" del serpente
Fonte
- Large-scale snake genome analyses provide insights into vertebrate development
Changjun Peng et al, (2023) Cell
***
L'antenato a quattro zampe del serpente
Spesso ci si dimentica che anche i serpenti sono tetrapodi come noi e quindi hanno un antenato a quattro zampe.
Trovare però l'anello di congiunzione tra la linea principale dei rettili (con arti visibili) e il sottordine dei Serpentes (in cui gli arti sono visibili come vestigia ossee) è tutt'altro che banale.
Oltre a fossili viventi come la lucertola mostrata nella figura a fianco, l'unico indizio fossile del percorso evolutivo che ha portato ai serpenti attuali è la Najash rionegrina, un estinto rettile scavatore in cui era evidente l'osso sacro, l'elemento chiave dei tetrapodi.
Mancava però il fossile di transizione tra animali come le moderne lucertole e la Najash.
Ad essere onesti il fossile era stato portato alla luce alcuni decenni fa, ma nessuno allora si accorse dell'esistenza delle minuscole zampette, finendo così come reperto semi-dimenticato in una collezione privata. Questo fino al casuale riesame compiuto da David Martill, un paleobiologo dell'università di Portsmouth che dopo averne scoperto i mini arti lo ribattezzò Tetrapodophis amplectus, vale a dire "serpente a quattro zampe in grado di afferrare".
Il proto-serpente mostrato nella foto misura 20 centimetri ed è dotato di due arti anteriori di circa 1 cm, completi di gomito, polso e dita. Le zampe posteriori sono leggermente più grosse e lunghe. Il fossile ha un chiaro aspetto serpentiforme con un tronco allungato, coda corta e scaglie ventrali a supporto di una locomozione serpentina. Il cranio e le proporzioni del corpo, così come la riduzione delle vertebre sono anch'esse a supporto di un adattamento scavatore, tutti dati a sostegno dell'ipotesi di un antenato terrestre.
Anche il cranio del Tetrapodophis mostra che si tratta di un animale terrestre adatto a scavare privo degli adattamenti necessari per una vita acquatica. La presenza di denti orientati verso l'interno suggerisce anche che fosse un feroce predatore; a riprova delle sue abitudini carnivore la presenza nelle viscere del fossile di ossa derivanti dal suo ultimo pasto. Le sue tecniche predatorie sono incerte ma la struttura corporea rende possibile che avesse già al tempo capacità di catturare la preda avvolgendosi intorno e magari fermandola con i mini arti.
Secondo l'autore il fossile dimostra che quando, durante l'evoluzione, il proto-serpente "smise di camminare" (ovviamente una frase sintetica che riassume milioni di anni di processi adattativi), i suoi arti non divennero inutili vestigia ma furono probabilmente utilizzati oltre che per afferrare la preda anche per trattenere il partner durante l'accoppiamento
Il luogo del ritrovamento (Brasile) e l'età del fossile (Cretaceo inferiore) indicano nel supercontinente del Gondwana l'area in cui è avvenuta la transizione.
Fonte
- A four-legged snake from the Early Cretaceous of Gondwana
David M. Martill et al, Science (2015) Vol. 349 no. 6246 pp. 416-419
Trovare però l'anello di congiunzione tra la linea principale dei rettili (con arti visibili) e il sottordine dei Serpentes (in cui gli arti sono visibili come vestigia ossee) è tutt'altro che banale.
 |
| Hemiergis quadrilineatum, un rettile australiano in cui sono ancora evidenti arti oramai "inutili". Nei serpenti il processo di riduzione si è spinto fino alla presenza di sole vestigia ossee (credit: reptilesofaustralia) |
Mancava però il fossile di transizione tra animali come le moderne lucertole e la Najash.
Nota. Due sono le teorie attuali, in contrasto tra loro, riguardo l'evoluzione dei serpenti. La prima ipotizza che derivino da animali marini spostatisi sulla terraferma, quindi già "quasi" privi di arti se non come vestigia ossee. La seconda teoria ipotizza invece che si siano evoluti da lucertole scavatrici adattatesi talmente bene alla vita nei cunicoli da avere perso ogni necessità degli arti.Si comprende meglio allora l'entusiasmo che la scoperta di un fossile vecchio di 113 milioni di anni di aspetto serpentiforme ma dotato di quattro zampe ha scatenato nel mondo dei paleobiologi; il ritrovamento ha infatti nel campo la stessa valenza che la scoperta dell'Australopithecus afarensis (noto ai più come Lucy) scatenò tra gli antropologi.
Ad essere onesti il fossile era stato portato alla luce alcuni decenni fa, ma nessuno allora si accorse dell'esistenza delle minuscole zampette, finendo così come reperto semi-dimenticato in una collezione privata. Questo fino al casuale riesame compiuto da David Martill, un paleobiologo dell'università di Portsmouth che dopo averne scoperto i mini arti lo ribattezzò Tetrapodophis amplectus, vale a dire "serpente a quattro zampe in grado di afferrare".
 |
| Dave Martill/University of Portsmouth cited in wired.uk |
Il proto-serpente mostrato nella foto misura 20 centimetri ed è dotato di due arti anteriori di circa 1 cm, completi di gomito, polso e dita. Le zampe posteriori sono leggermente più grosse e lunghe. Il fossile ha un chiaro aspetto serpentiforme con un tronco allungato, coda corta e scaglie ventrali a supporto di una locomozione serpentina. Il cranio e le proporzioni del corpo, così come la riduzione delle vertebre sono anch'esse a supporto di un adattamento scavatore, tutti dati a sostegno dell'ipotesi di un antenato terrestre.
Anche il cranio del Tetrapodophis mostra che si tratta di un animale terrestre adatto a scavare privo degli adattamenti necessari per una vita acquatica. La presenza di denti orientati verso l'interno suggerisce anche che fosse un feroce predatore; a riprova delle sue abitudini carnivore la presenza nelle viscere del fossile di ossa derivanti dal suo ultimo pasto. Le sue tecniche predatorie sono incerte ma la struttura corporea rende possibile che avesse già al tempo capacità di catturare la preda avvolgendosi intorno e magari fermandola con i mini arti.
Secondo l'autore il fossile dimostra che quando, durante l'evoluzione, il proto-serpente "smise di camminare" (ovviamente una frase sintetica che riassume milioni di anni di processi adattativi), i suoi arti non divennero inutili vestigia ma furono probabilmente utilizzati oltre che per afferrare la preda anche per trattenere il partner durante l'accoppiamento
Il luogo del ritrovamento (Brasile) e l'età del fossile (Cretaceo inferiore) indicano nel supercontinente del Gondwana l'area in cui è avvenuta la transizione.
(articolo precedente sul tema --> "Reperti ossei dell'antenato dei serpenti")
Fonte
- A four-legged snake from the Early Cretaceous of Gondwana
David M. Martill et al, Science (2015) Vol. 349 no. 6246 pp. 416-419