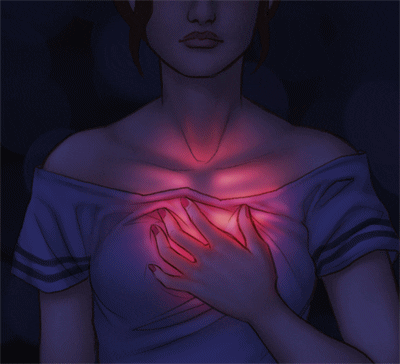Musica e rischio mentale
Tempo fa scrissi del connubio (spesso presente) tra arte e follia (articolo in calce al presente)
Oggi amplio le precedenti tematiche per citare un recente studio circa la correlazione tra propensione/possedere abilità musicali e la predisposizione per alcune malattie mentali.
 |
| Image is in the public domain |
È pensiero comune che fare musica sia un toccasana non solo spirituale ma anche come strumento educativo per i giovani e anche per chi soffre di problemi fisici o mentali (vedi la musicoterapia). Altrettanto comune però la conoscenza di musicisti (e non parlo di chi non è ma tale si considera come i Fedez etc) che mostrano comportamenti dal pittoresco al nevrotico/ossessivo/tormentato). Rispetto alle persone “musicalmente inattive”, i musicisti sembrano in effetti più colpiti da depressione e disturbi d'ansia (pur escludendo le “rockstar” i cui problemi possono essere secondari al loro stile di vita).
Per indagare su questa correlazione un team tedesco-svedese che ha portato avanti un primo studio, pubblicato su Scientific Report nel 2019 .
In questo studio i ricercatori coinvolsero 10500 gemelli svedesi a cui chiesero informazioni sia sul loro impegno musicale che sulla loro salute mentale; i dati ottenuti vennero poi incrociati con il registro nazionale dei pazienti e in particolare con la sezione disturbi mentali. L’essere gemelli (mono- o di-zigoti) permetteva di pesare la componenente genetica e ambientale nella frequenza di tali disturbi.
I risultati evidenziarono che i partecipanti musicalmente attivi erano più a rischio, in modo statisticamente significativo, di depressione, esaurimento e altri disturbi psicotici rispetto a chi non lo era.
In particolare l'impegno musicale, come suonare uno strumento o cantare, e i problemi di salute mentale probabilmente non sono correlati in modo causale. Per dirla meglio, le persone non fanno musica in risposta ai loro problemi di salute mentale o viceversa. Piuttosto, il collegamento può essere attribuito a fattori genetici condivisi e/o ad influenze dall'ambiente familiare.
In questi ultimi anni i ricercatori hanno continuato i loro studi, indagando più la parte di genetica molecolare. I risultati sono stati pubblicati qualche settimana fa sulla rivista Translational Psychiatry.
Condensando il tutto in una frase, lo studio ha confermato che le varianti genetiche che influenzano i problemi di salute mentale e quelle che influenzano l'impegno musicale hanno un buon grado di sovrapposizione.
Nel dettaglio il team ha esaminato il legame genetico tra il fare musica e la salute mentale utilizzando il DNA di 5.648 individui. Oltre ai dati sul genotipo, i partecipanti allo studio hanno fornito informazioni sul loro impegno musicale, sui risultati creativi e sportivi e sulla loro salute mentale.
Sulla base delle informazioni così ottenute sono stati “creati” indicatori individuali, chiamati "punteggi poligenici", che racchiudono sia il rischio genetico dei partecipanti per le malattie mentali che la loro predisposizione (genetica) alla musicalità. Il punteggio ha rivelato che gli individui con un rischio genetico più elevato di depressione e disturbo bipolare erano, in media, musicalmente attivi, si esercitavano di più e possedevano un livello artistico più elevato (esercitarsi molto non è sinonimo di essere musicalmente dotati). È interessante notare che le associazioni sussistevano indipendentemente dal fatto che gli individui manifestassero effettivamente i problemi di salute mentale per cui erano geneticamente a rischio.
Allo stesso tempo, i partecipanti con una maggiore predisposizione genetica per la musicalità avevano anche, in media, un rischio leggermente più alto di sviluppare la depressione, indipendentemente dal fatto che suonassero o meno uno strumento.
Questi risultati forniscono ulteriore supporto all'idea che in parte gli stessi geni influenzino l'impegno musicale e la salute mentale.
La relazione complessiva tra il fare musica e la salute mentale è molto complessa: fattori familiari e genetici possono influenzare sia la musicalità che la salute mentale. Non superfluo sottolineare che questi risultati non escludono la possibilità che il fare musica abbia una influenza positiva sullo stato mentale come ben noto dalla aneddotica medica di persone che trovano sollievo dai loro disturbi solo durante l’attività musicale.
I ricercatori stanno approfondendo le loro ricerche tenendo conto anche delle esperienze di “flow” (flusso). “Flusso” si riferisce all'esperienza di completo assorbimento in un'attività
I risultati iniziali mostrano che le esperienze di flusso possono avere un'influenza positiva sulla salute mentale, anche una volta normalizzati i fattori esperienziali e genetici
Fonti
- "The effects of playing music on mental health outcomes"
- "A comprehensive investigation into the genetic relationship between music engagement and mental health"
***
Il difficile equilibrio tra creatività e disturbo mentale
(22/4/2013)
Pensare fuori dagli schemi è il paradigma di chiunque si caratterizzi come un innovatore nelle arti e nei mestieri. Una caratterizzazione a volte così marcata da generare lo stereotipo dello "scienziato pazzo" o dell'artista "strambo", persone talmente prese dalla loro opera da dimenticarsi del mondo circostante. Non è raro invero imbattersi in artisti (termine qui usato nel senso letterale del termine, chi pratica le
ars e svolge quindi attività creative) il cui comportamento supera il confine del peculiare per sforare nel patologico.
 |
| (®Dreamstime) |
Un dato confermato, numeri alla mano, da una ricerca pubblicata da un team svedese sul Journal of Psychiatric Research. Secondo lo studio, le persone impegnate in professioni creative (ivi compresi noi ricercatori) hanno una incidenza di disturbi mentali, come disturbo bipolare e schizofrenia, superiore alla frequenza media osservata nella popolazione generale. In particolare sembra che tra l'essere scrittori e soffrire di schizofrenia il legame non sia propriamente casuale.

Diciamocelo, il dato in sé non stupisce più di tanto, complice l'immagine dello scrittore alienato immerso in un mondo fittizio il cui comportamento precipita nella follia (uno su tutti il protagonista di
Shining, interpretato al cinema dal magistrale
Jack Nicholson). Posso altresì testimoniare una uguale presenza di soggetti "curiosi", in alcuni casi francamente alterati, tra i ricercatori che ho conosciuto in questi anni; alcuni dei quali senza dubbio geniali e veri innovatori.
Tornando all'ambito artistico, Van Gogh e Cimabue sono due esempi ben noti anche al grande pubblico. Trovare un artista innovativo con un comportamento nella norma ("normale" è un termine ovviamente inutilizzabile per descrivere le molteplici sfumature del comportamento umano) è più difficile.
Ma forse per comprendere l'associazione bisogna ribaltare la prospettiva, "Creo appunto perchè il soffrire di alcuni disturbi mi rende più facile il pensare oltre gli schemi".
Non voglio approfondire qui la relazione tra arte e follia. Esistono siti e libri molto ben fatti sull'argomento in grado di fornire un quadro ben più esaustivo di quello che le mie competenze sull'argomento permetterebbero (vedi note a fondo pagina).
Mi interessa oggi riportare le conclusioni a cui sono giunti i ricercatori del
Karolinska Institutet di Stoccolma, al termine di uno studio su un campione di svedesi estremamente ampio, pari a circa
1,2 milioni di persone. Considerando i controlli (in genere
almeno uguali in numero rispetto ai
casi) necessari per dare validità statistica all'analisi, il numero di individui inclusi nello studio rappresenta la gran parte della popolazione svedese!!
Ma procediamo con ordine.
Si è partiti con l'analizzare, con garanzia di anonimato e di non rintracciabilità a partire dai dati aggregati, le persone impegnate in attività creative valutando la presenza, in essi e nei familiari fino al secondo grado, di disturbi schizoaffettivi come depressione o ansia, abuso di alcol o droghe, autismo, sindrome da iperattività (ADHD), anoressia nervosa e autolesionismo.
Il tutto stando bene attenti a includere non solo i soggetti ospedalizzati ma anche quelli curati in remoto.
I risultati odierni sommati a quelli di uno studio precedente più circoscritto indicano che alcune malattie mentali - ad esempio il disturbo bipolare - sono più frequenti tra le persone che svolgono attività creative come ballerini, ricercatori, fotografi e scrittori. Gli scrittori in particolare oltre ad una maggiore incidenza di schizofrenia, depressione, ansia e abuso di sostanze, hanno quasi il 50 per cento di probabilità in più di commettere suicidio rispetto alla popolazione generale.
Secondo Simon Kyaga, consulente in psichiatria e dottorando presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Biostatistica, i risultati inducono a riconsiderare l'approccio terapeutico alla malattia mentale. "Se si ritiene che certi fenomeni associati con la malattia del paziente sono "utili" [percepiti come tali dal soggetto n.d.b], si apre la strada ad un nuovo approccio al trattamento", dice Kyaga. "Il medico e il paziente devono giungere ad un accordo su cosa [sintomi] curare, e a quale costo. Fino a pochi anni fa in psichiatria vi era la tendenza di vedere la malattia in bianco o nero, usando un approccio terapeutico radicale per eliminare qualunque atteggiamento anomalo".
Ridurre tutto ad assenza di sintomi "strani" finisce infatti con l'appiattire la personalità spegnendo la fiamma del genio che necessariamente coincide con il vedere le cose da una prospettiva diversa e, per alcuni, anormale. Intraprendere un percorso terapeutico mirato INVECE ad eliminare gli aspetti negativi (e vissuti come tali dal soggetto o da chi in famiglia ne condivide le manifestazioni) incanalando le tensioni all'interno di attività catartiche è chiaramente una innovazione importante. Un percorso terapeutico che affronti insieme al soggetto il rapporto rischio (vale a dire ciò che si perde) - beneficio permetterebbe di intervenire in modo mirato sugli aspetti neurologici più opprimenti per il paziente, salvaguardando nel contempo la sua creatività.
Del resto se come dice un vecchio adagio "nessuno da vicino è normale", la ricerca attuale dice che gli artisti lo sono meno di tutti.
Fonti
-
Karolinska Institute, news
-
Mental illness, suicide and creativity: 40-Year prospective total population study
Simon Kyaga, Mikael Landén, Marcus Boman, Christina M. Hultman och Paul Lichtenstein
Journal of Psychiatric Research, corrected proof online 9 October 2012
- Arte e Pazzia
Enrico Da Campo,
sito web
-
La Bella e la Bestia: Arte e Neuroscienze
Ludovica Lumer, Semir Zeki (Laterza, 2011)






_-_lateral_view.png/800px-Prefrontal_cortex_(left)_-_lateral_view.png)