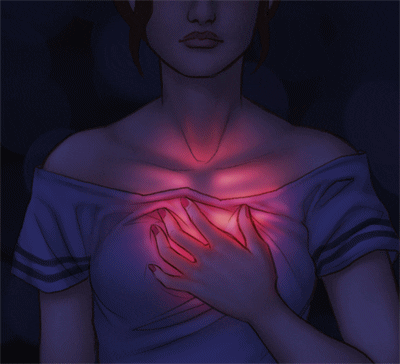Per quanto possa suonare strano alcuni dati recenti sembrano indicare che, almeno nei topi, è possibile aumentare la resilienza agli effetti dello stress mediante i batteri.


La ricerca, pubblicata su PNAS (Proceedings of National Academy of Sciences) da ricercatori della università del Colorado, mostra che è possibile aumentare la resistenza allo stress nei topi maschi (come evidenzia il calo di paura e ansia nell'affrontare situazioni difficili) iniettando loro un particolare tipo di batteri in forma inerte (uccisi dal calore).
Da un punto di vista neurochimico tali effetti appaiono correlati alla variazione del livello di serotonina nel cervello in modo non troppo diverso da quanto indotto dagli antidepressivi o da rimedi naturali come una costante attività sportiva (fenomeno ben noto a chi fa jogging tutte le mattine). Non si tratta solo di effetti positivi sull'umore ma soprattutto di una maggiore protezione alla colite indotta da stress (anche questa ben nota) causata da un cronico stato infiammatorio intestinale.
Il batterio usato, Mycobacterium vaccae, è un batterio innocuo (almeno nei soggetti immunocompetenti) molto diffuso nell'ambiente.
Una piastra con colture di M. vaccae
(courtesy: exploringtheinvisible.com)Sebbene possa sembrare inverosimile che un batterio abitante nel suolo abbia una azione benefica per la salute mentale, bisogna sempre ricordare che la nostra salute fisica è strettamente correlata con il microbiota, la massa di microorganismi che noi ospitiamo sia sulla cute che nell'apparato gastrointestinale (maggiori dettagli --> QUI). Uno squilibrio (o una perdita come avviene dopo la terapia antibiotica) in queste popolazioni produce effetti su più livelli sia per la diminuita competizione tra microbi che favorisce la diffusione dei ceppi patogeni che per la nostra ridotta capacità di metabolizzare le sostanze ingerite. Non da ultima l'azione da "sparring partner" che il microbiota ha con il nostro sistema immunitario, che viene tenuto "allenato" e "calibrato", prevenendone eccessi reattivi: è noto infatti che i bambini cresciuti in un ambiente "iper-sanitizzato" hanno una maggiore probabilità di sviluppare allergie e asma, entrambe manifestazioni di una eccessiva e poco regolata attività immunitaria.
Se il possedere un sistema immunitario "allenato" è importante per l'efficacia delle nostre difese e per diminuire la possibilità di reazioni autoimmuni, non deve nemmeno sorprendere che problemi nella sua regolazione, come avviene in uno stato infiammatorio cronico, siano forieri di disturbi a livello centrale come quelli psichiatrici.
Un tema questo ben descritto nel testo oramai classico di Michael Gershon sull'intestino come "secondo cervello". I microbi intestinali sono, cosa importantissima ma poco nota, i principali produttori della serotonina, il nostro neurotrasmettitore "dell'umore" (--> Caltech). Per maggiori informazioni vi invito ad ascoltare l'intervista al prof. Piero Cortelli andata in onda a Moebius su Radio24 (--> mp3).
I disturbi psichiatrici causati da stress (cronico o acuto) sono un problema particolarmente importante nei veterani di guerra e in generale nelle persone traumatizzate da eventi violenti. Queste sindromi (post-traumatic stress disorder - PTSD) sono associate ad uno stato infiammatorio cronico causato dallo stress.
Torniamo al M. vaccae e ai suoi effetti terapeutici nei topi di laboratorio.
Il batterio si è rivelato capace di normalizzare colite e alcuni sintomi psichiatrici proprio grazie alla sua azione sul sistema immunitario, forzato a spegnere le attività ridondanti causa del permanere dello stato infiammatorio.
Il batterio si è rivelato capace di normalizzare colite e alcuni sintomi psichiatrici proprio grazie alla sua azione sul sistema immunitario, forzato a spegnere le attività ridondanti causa del permanere dello stato infiammatorio.
Nello specifico, i ricercatori hanno confrontato la risposta comportamentale in due gruppi di topi maschi, uno iniettato con un placebo e l'altro con una miscela di batteri uccisi dal calore, in grado però di attivare la risposta immunitaria. Dopo l'immunizzazione i topi sono stati fatti coabitare per 19 giorni con un maschio dominante, una situazione che induce nel maschio "ospite" un comportamento remissivo e uno stato di stress esattamente come avviene negli esseri umani quando sono forzati a rimanere in una situazione non voluta.
I topi immunizzati con i batteri presentavano livelli di stress alla vista del maschio dominante inferiori del 50% rispetto ai controlli trattati con placebo.
Lo stato "non stressato" si protraeva per almeno due settimane dopo il trattamento ed era associato ad un miglioramento dei parametri fisiologici del topo. In altre parole i topi trattati stavano meglio e mostravano un atteggiamento pro-attivo e un maggiore controllo della situazione.
E' bene precisare che tale stato non era configurabile come un "minor rispetto verso il dominante", situazione che avrebbe innescato confronti fisici tra i due; il topo ospite continuava a mostrarsi cauto verso ogni situazione di pericolo e sottomesso al "capo", senza però lo stato di panico evidente nel gruppo di controllo. Un esempio diametralmente opposto che mostra il caso in cui la riduzione di paura è "patologica" lo si ha nei topi affetti da toxoplasmosi che ... smettono di avere paura dei gatti, con conseguenze facilmente immaginabili (--> articolo).Stesse conclusioni dalla osservazione di una delle attività più comuni nei roditori, quella dell'esplorazione dell'ambiente, ed una delle prime a venire meno nei topi stressati; i topi trattati mantenevano una curiosità inalterata durante le loro passeggiate esplorative.
Lo stato "non stressato" si protraeva per almeno due settimane dopo il trattamento ed era associato ad un miglioramento dei parametri fisiologici del topo. In altre parole i topi trattati stavano meglio e mostravano un atteggiamento pro-attivo e un maggiore controllo della situazione.
L'iniezione di M. vaccae, a differenza di un vaccino classico NON è finalizzata a presentare al sistema immunitario un particolare antigene (e quindi ad innescare una risposta verso esso o come avviene nella cura delle allergie ad indurre una tolleranza), ma serve per attivare le risposte immunomodulanti che sono alla base del corretto funzionamento (autoregolazione) della risposta immunitaria.
Se il dato venisse confermato in essere umano, si aprirebbero interessanti prospettive terapeutiche nel trattamento delle patologie da stress.
Se il dato venisse confermato in essere umano, si aprirebbero interessanti prospettive terapeutiche nel trattamento delle patologie da stress.
Articoli precedenti sul tema PTSD: "Cancellare gli incubi"; "Stress post-traumatico ..."
Fonte
- Immunization with Bacteria Promotes Stress Resilience, Coping Behaviors in Mice
University of California San Diego, news