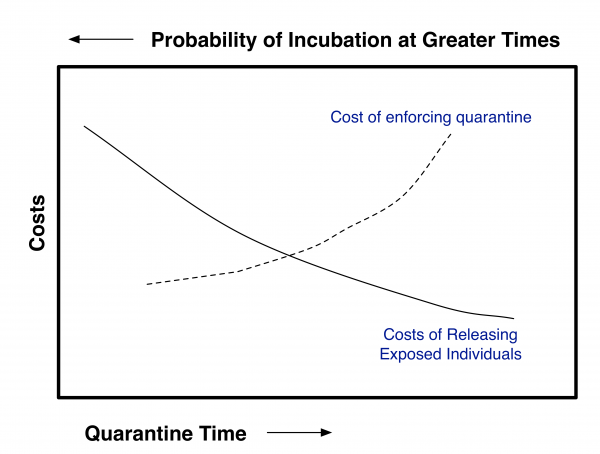Alzheimer. Migliorare lo stato cognitivo e mnemonitco è possibile (forse)... ma solo se la malattia è in fase iniziale e se verranno confermati i risultati ottenuti da un team della University of California- Los Angeles (UCLA).
 |
| (credit: alzinfo) |
Il morbo di Alzheimer (AD) è una patologia neurodegenerativa ad alto impatto umano e sociale, destinato a crescere nei prossimi anni a causa dell'aumento dell'età media e per l'assenza di terapie adeguate.
Intendiamoci, invecchiare NON è un accidente imprevisto che possa essere eliminato con una pillolina o una dieta attenta. E' vero che non si tratta di un fenomeno tipico di ogni organismo vivente ma di sicuro l'invecchiamento inteso come decadimento delle facoltà fisiche è una
caratteristica comune a tutti i mammiferi (articolo centrato su questo tema,
QUI).
Quindi più che combattere l'invecchiamento in sé, è molto più sensato cercare di comprendere quali siano i fattori di rischio genetico e ambientale in grado di spiegare perché il 30% circa degli ultraottantenni sviluppa l'AD mentre i rimanenti, al netto di altre forme patologiche, mantengano capacità intellettive nella norma. Comprendere cause e fattori di rischio di una patologia è il passaggio obbligato per identificare le persone più a rischio e disegnare su di esse trattamenti in grado di rallentare o bloccare l'insorgere dei sintomi.
Cosa ben diversa questa dal cercare di invertire o bloccare l'invecchiamento tout court.
Una sfida su cui sono da anni impegnati molti laboratori di ricerca ma che finora ha fornito "solo" dati scientificamente interessanti ma troppo "vaghi" per poter essere utilizzati per sviluppare una terapia. Una "vaghezza" (virgolettato non casuale) che non dipende dalla qualità degli studi ma è la diretta conseguenza della complessità di una malattia che poggia su basi eterogenee.
Il 99% dei casi di AD è "sporadico", ossia si
manifesta in persone che non hanno una chiara familiarità. Solo l'1% dei
casi è causato da un gene alterato che ne
determina la trasmissione da una generazione all'altra. Ad oggi sono tre i geni le cui mutazioni sono associate all'AD.
 |
| Le differenze tra un cervello sano e quello di un soggetto con Alzheimer avanzato (©wikipedia) |
Di particolare interesse uno studio recentemente apparso sulla rivista
Aging, prodotto da un team della UCLA guidato da
Dale Bredesen, in cui si descrive un
approccio su più livelli volto a bloccare sul nascere i sintomi della malattia. Il che è già di suo una notizia dato che al momento
NON esiste alcun trattamento minimamente soddisfacente in grado di rallentare la comparsa dei sintomi e tanto meno in grado di produrre dei miglioramenti. Date le premesse, i dubbi con cui mi sono avvicinato all'articolo erano notevoli. Dopo averlo letto ritengo valga la pena commentarlo.
C'è da sottolineare che lo studio è assolutamente preliminare e con nulla significatività statistica essendo stato condotto su un micro campione di pazienti (dieci), ciascuno dei quali è stato sottoposto ad un programma terapeutico personalizzato il cui fine era rallentare la perdita di memoria.
Un obiettivo alquanto ambizioso e su cui era ben difficile scommettere dato che i sintomi dell'Alzheimer (e di gran parte delle altre malattie neurodegenerative) compaiono quando già il danno cerebrale è rilevante. Una volta perse le connessioni neuronali anche la memoria associata viene persa e sperare di avere miglioramenti funzionali quando viene a mancare il substrato cellulare è molto arduo da ipotizzare anche in un organo che fa della plasticità il suo punto di forza.
Tuttavia ... lo studio ha mostrato un miglioramento, soggettivo e oggettivo, in 9 dei 10 pazienti trattati. E questo è un dato di fatto.
Un dettaglio riportato sul sito news della UCLA aiuta a capire meglio il risultato. Al momento dell'inizio dello studio, sei dei pazienti reclutati avevano dovuto congedarsi dalle loro mansioni lavorative (in genere associate a responsabilità organizzative complesse) a causa della oggettiva impossibilità, da loro stessi riscontrata, a svolgere mansioni intellettualmente impegnative. Ebbene, dopo un certo numero di mesi dall'inizio del trattamento tutti e sei hanno potuto riprendere il lavoro dati i miglioramenti conseguiti.
Niente di miracoloso sia chiaro ma un ritorno a sintomi "accettabili".
Quanto tempo è durata la terapia? Meglio riformulare la domanda in altro modo dato che stiamo parlando di malattie progressive con le quali non è ipotizzabile un trattamento una tantum (almeno finché non si agirà sulle cause prime della malattia).
E' come immaginare una barca con una falla invisibile ai nostri occhi ma di cui vediamo l'effetto con il progressivo innalzamento del livello dell'acqua; l'unica soluzione disponibile è quella di svuotare la barca con un piccolo recipiente. Se il livello sale molto lentamente possiamo continuare a navigare per un certo periodo di tempo. Ma non appena smettiamo l'acqua torna a salire.
Meglio allora chiedere dopo quanto tempo dall'inizio della terapia si è cominciato ad osservare un miglioramento.
Il paziente in trattamento da più tempo è sotto terapia da due anni e mezzo, mentre per i primi segnali positivi è necessario attendere (nei soggetti responsivi) almeno tre mesi.
Ricordiamo ancora una volta che i pazienti ammessi allo studio erano nella fase iniziale della malattia, caratterizzata da perdita di memoria, lieve decadimento cognitivo, amnesia o deterioramento cognitivo soggettivo (percepito cioè dal paziente). Dei 10 partecipanti 9 presentavano sintomi lievi ma significativi, mentre il decimo era in fase più avanzata. Non a caso quest'ultimo soggetto è stato anche l'unico a non mostrare miglioramenti degni di nota durante il trattamento.
E' lo stesso Bredesen a sottolineare che sebbene i risultati siano "molto incoraggianti", il numero assolutamente esiguo del campione rende questi eventi "aneddotici". E' semplicemente una indicazione che consente di portare avanti la sperimentazione reclutando un numero molto maggiore di soggetti all'interno di uno studio clinico controllato.
D'altro canto non si può non tenere presente che per quanto aneddotico sia il risultato questo è il primo studio a mostrare che la perdita di memoria nei pazienti può essere invertita.
In cosa consiste allora il programma "riabilitativo"?
In sintesi (vedere l'articolo originale per ulteriori dettagli) si tratta di un programma complesso basato su 36 punti che agisce su molteplici livelli. Seguendo il detto "mens sana in corpore sano", si agisce ANCHE cambiando drasticamente la dieta, promuovendo esercizio fisico e ottimizzazione del sonno. I trattamenti farmacologici ci sono e sono diversi a seconda delle caratteristiche del paziente, e possono prevedere l'uso di vitamine. Infine si sfruttano una serie di altre attività in grado di agire sulla "chimica" del cervello.
Il razionale alla base di questo approccio multi-fattoriale nacque dalla constatazione che "negli ultimi dieci anni sono stati condotti centinaia di studi
clinici sull'Alzheimer, tutti senza successo e con costo superiore a 1 miliardo di dollari [NDB secondo me il dato monetario è
fortemente in difetto]".
Mentre i progressi
nell'ambito di altre malattie croniche come le patologie cardiovascolari e
il cancro (ma anche l'infezione da HIV) sono stati continui e concreti, molto meno rilevanti sono i risultati (in ambito terapeutico) nel campo delle malattie neurodegenerative.
Proprio il fallimento degli approcci classici ha spinto Bredesen a cercare di comprendere meglio la natura fondamentale della malattia percorrendo strade meno battute. Dal lavoro condotto dalla sua equipe nel corso degli ultimi anni sono emerse le prove che l'AD deriva da uno squilibrio nella segnalazione delle cellule nervose e non solo dalla morte delle cellule, che rappresenta il punto finale e senza ritorno.
La "perdita della memoria" è in effetti una modalità operativa assolutamente normale nel cervello sano, un processo che impedisce il consolidarsi di ogni singolo evento sperimentato sensorialmente. E' l'equilibrio tra segnali opposti (che favoriscono o impediscono la stabilizzazione di connessioni sinaptiche) l'elemento cardine del cervello normale: alcuni stimoli favoriscono il consolidamento della memoria, altri (o l'assenza di altri) aumentano la labilità della connessione, evento che impedisce la formazione della memoria.
Nelle persone con AD è l'equilibrio di questi segnali opposti ad essere alterato. Se il processo di consolidamento viene meno, né risulta lo spostamento dell'equilibrio verso la labilità delle connessioni nervose. Proprio quello che avviene nell'AD dove è la capacità di formare nuove memorie la prima ad essere persa.
Un concetto quindi diverso da quello conosciuto ai più, e oramai in parte superato, che vede(va) nell'accumulo delle
placche amiloidi la causa della malattia. Bredesen ritiene che il peptide
beta amiloide, da cui originano le placche, abbia una funzione assolutamente fisiologica nel cervello, come la hanno tutte le molecole coinvolte nel processo della "fisiologica labilità della memoria". Nell'AD il problema sarebbe non nella beta amiloide ma nell'assenza di segnali di segno opposto, cioè di segnali che favoriscono il consolidamento della memoria.
Guardando alle nuove terapie sperimentate con successo su altre malattie il dato che emerge è che solo raramente (e per malattie monofattoriali) un solo trattamento è risolutivo. Molto più spesso è necessario agire su molti bersagli per avere una ragionevole certezza di efficacia.
Allora forse il punto chiave è proprio nel passare da un approccio univalente (ottimo per malattie monofattoriali) all'uso di terapie combinate in grado di agire su più livelli. Da qui l'idea di sviluppare l'approccio a 36 punti sopra accennato, "cucendolo" però sulle caratteristiche specifiche del paziente.
Nel caso specifico di un suo paziente che svolgeva mansioni lavorative intellettualmente impegnative e che si era accorto un giorno di non ricordarsi più la strada di casa, la terapia provata ha usato solo alcuni dei 36 punti del programma. Di seguito i punti principali:
- eliminazione dalla dieta di tutti i carboidrati semplici, glutine e alimenti trasformati. Mangiare più verdure, frutta e pesce non d'allevamento.
- Yoga e attività meditativa finalizzate a minimizzare lo stato di stress (e le conseguenze che questo comporta).
- Dormire sette-otto ore per notte ma con sveglia prima dell'alba (tra le 4 e le 5)
- Prendere melatonina, metilcobalamina, vitamina D3, olio di pesce e coenzima Q10 ogni giorno (sul tema "vitamine utili per malattie neurodegenerative?" vai QUI).
- Curare attentamente l'igiene orale allo scopo di minimizzare gli stati infiammatori.
- Nel caso specifico essendo una donna, si è riattivata la terapia ormonale sostitutiva, precedentemente interrotta.
- Minimo 12 ore di digiuno tra cena e prima colazione, e un minimo di tre ore tra la cena e il momento di coricarsi.
- Almeno 30' di attività fisica giornaliera, 4-6 giorni alla settimana
Il programma non è banale e impone la stretta collaborazione di pazienti, familiari e personale paramedico di supporto. Non a caso nessuno dei pazienti nello studio è stato in grado di rispettare l'intero protocollo; le lamentele più comuni riguardavano i cambiamenti di dieta e di stile di vita, oltre al dover prendere più pillole ogni giorno.
Nondimeno si tratta di un approccio altamente salutista i cui benefici si sono osservati sia con i test cognitivi che medici (migliore indice di massa corporea e quindi minori complicanze.
E' un metodo scientificamente sensato? Diciamo che male non fa specie considerando che
non c'è alternativa e che per quanto anedottici i risultati si sono visti.
Di sicuro ha giocato un ruolo non secondario il fatto che i pazienti reclutati in questo primo micro studio erano tutti soggetti motivati (probabilmente anche grazie al loro livello di
istruzione); il fatto stesso di avere percepito loro stessi la comparsa di sintomi che sarebbero stati trascurati dalla maggior parte delle altre persone, ne è la prova e ha permesso l'inizio del trattamento in una fase ideale.
Una alimentazione adatta non è solo utile alle persone anziane con evidenze di Alzheimer ma alla popolazione anziana in generale proprio per prevenire o limitare il declino della capacità cognitive (vedi a tal proposito uno studio del Karolinska Institute di Stoccolma --> QUI)
La parola finale spetta però solo alla clinica e questa verrà solo quando un numero sufficientemente alto di soggetti potranno essere reclutati e i risultati valutati rigorosamente; di sicuro studi randomizzati ma ben difficilmente in doppio cieco, per ovvi motivi.
(per altri articoli sul tema "Alzheimer e ricerca" --> Alzheimer)
Fonti
- Memory loss associated with Alzheimer’s reversed for first time.
UCLA/news (2 ottobre 2014)
- Reversal of cognitive decline: A novel therapeutic program
Dale E. Bredesen, (2014) Aging, 6 (9) pp. 707-717