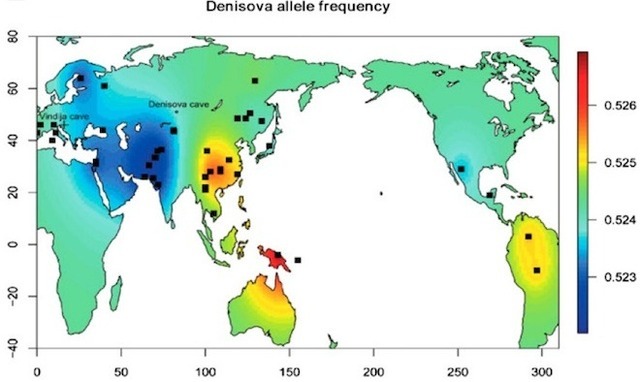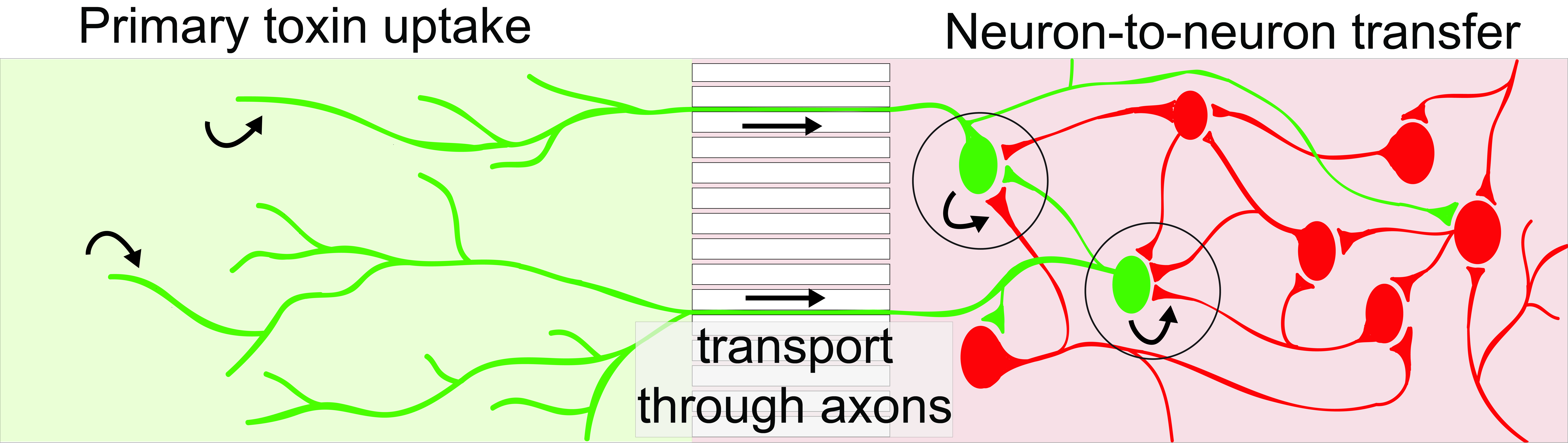In un precedente articolo descrissi l'affascinante susseguirsi di eventi che portò alla scoperta del ramo "denisoviano" del genere Homo. Un "parente" fino ad allora sconosciuto, ed estinto, tra quelli più prossimi a noi, oltre agli arcinoti neanderthal (vedi
QUI).
Due furono i "miracoli" che resero possibile questa scoperta:
- il riconoscimento (come tale) di un mini reperto, trovato in un'area ricca di fossili neanderthaliani, riconducibile ad un piccolo ossicino delle falangi (vedi foto a lato);
- l'eccezionale stato di conservazione che ha permesso non solo di estrarne il DNA ma di ottenere l'intera sequenza genomica. E furono proprio i dati genomici (grazie alla comparazione delle sequenze di riferimento) ad evidenziare che non si trattava di un fossile neandertaliano e tanto meno di un sapiens pur essendone chiaramente "parente". Il reperto doveva appartenere ad una altra specie di ominide, ribattezzato Homo denisova. Articolo successivo sul tema --> Ricostruito l'aspetto di un denisoviano grazie alla epigenetica.
 |
| l frammento osseo da cui si è risaliti al genoma denisovano
(credit: MPI for Evolutionary Anthropology, Germany) |
|
Il termine "specie" in realtà non sarebbe corretto in quanto in biologia tale attributo identifica organismi strettamente imparentati ma non in grado di generare progenie fertile (esempio classico di specie diverse sebbene molto affini sono l'asino e il cavallo la cui progenie è sterile). Dato che tutte le popolazioni non-africane (e vedremo sotto perché) hanno conservano tracce genetiche di Neandertal (tutti) e di Denisova (principalmente melanesiani, tibetani e alcune popolazioni delle Filippine), gli incroci tra sapiens e denisoviani sono avvenuti e hanno, ovviamente, generato una prole fertile. Quindi sarebbe meglio catalogare questo ramo del nostro albero genealogico come sub-specie.
I dati genetici ci mostrano che i nostri antenati non avevano remore di fronte alla prospettiva di accoppiarsi con altri ominidi. Questo è da sempre noto per quanto riguarda le primissime fasi dell'evoluzione del genere Homo (quando ancora risiedeva in Africa) ma per quanto riguarda il sapiens è sempre stato fonte di dibattito. Prima di tutto perché non si era sicuri del fatto che sapiens e neandertal si fossero mai incontrati e poi perché era difficile fare previsioni sulla compatibilità genetica tra i due. Le conoscenze (oltre all'evoluzione della tecnologia) derivate dal completamento del Progetto Genoma hanno fugato i dubbi dimostrando la presenza di DNA neandertaliano in tutte (e solo) le popolazioni sapiens non africane. Una acquisizione fondamentale nel processo di adattamento alle zone climaticamente sfavorevoli che il sapiens (ultimo tra gli ominidi ad abbandonare l'Africa) si trovò ad affrontare nel suo percorso dal medio-oriente verso Europa e Asia. Una rotta che lo portò a transitare in aree abitate da cugini Neandertal già adattatisi (vivevano li da almeno 100 mila anni) ai climi più freddi e meno luminosi del nord. Questa la ragione che spiega perché le odierne popolazioni africane siano prive di ogni traccia di neandertal e perché etnie anche molto lontane tra loro (un calderone che va dal melanesiano al nativo americano all'europeo) ne siano invece dotate.
Nota. Il genoma della maggior parte degli europei e asiatici contiene il 2-4% di DNA neanderthaliano. Il DNA denisoviano oscilla tra tracce minime fino al 5% del genoma dei melanesiani.
Ora a distanza di qualche anno dalla scoperta dell'Homo denisova nuovi dati permettono di collocare i tibetani tra gli eredi dei denisoviani e di spiegarne così il loro "rapido" (geneticamente parlando) adattamento alle alte quote.
 |
I tibetani e la loro "innata" capacità di vivere ad alta quota (Credit: Beijing Genomics Institute via domeonline.co.nz)
|
Andiamo con ordine.
Vivere ad alta quota non è semplice per il nostro organismo principalmente a causa della bassa pressione di ossigeno che da 159 mm Hg a livello del mare si abbassa a 110 mm Hg a 3000 metri.
Gli alpinisti professionisti conoscono i rischi associati al mal di montagna (che può comportare un semplice mal di testa ma degenerare in edema polmonare e morte) e li minimizzano mediante un graduale processo di adattamento o limitando il tempo di permanenza ad alta quota.
La bassa percentuale di ossigeno attiva meccanismi regolatori distinti a seconda del tempo di permanenza in tali condizioni. Nel breve termine (ore o
giorni) l'aumento della frequenza respiratoria e del battito
cardiaco faciliterà l'ossigenazione dei tessuti compensando così la minore efficienza di carico dell'ossigeno sull'emoglobina (costruita per essere
"saturata" a pressioni parziali di ossigeno maggiori). A lungo andare tuttavia
questo sforzo circolatorio provocherebbe un eccessivo affaticamento al sistema respiratorio e vascolare, motivo per cui entrano in azione
contro-misure più efficaci e durature come l'aumento degli eritrociti e del volume
ematico che aumentano l'emoglobina circolante e la capacità di perfusione dei tessuti. In parallelo si ha un lieve aumento del numero di mitocondri e del livello di enzimi ossidativi così da massimizzare la capacità cellulare di utilizzare l'ossigeno.
Lo
svantaggio di questo adattamento è la maggiore viscosità del sangue dovuta ad una aumentata cellularità, da cui l'aumentato rischio di problemi cardiovascolari per chi vive ad alta quota. Altri problemi noti sono un alto tasso di mortalità infantile.
Nonostante queste premesse, i
tibetani sono un mirabile esempio di popolo perfettamente adattato al proprio ambiente. I motivi, come ovvio, sono rintracciabili nella genetica e, cosa per me più interessante, nella antropologia evolutiva.
Uno studio pubblicato su
Nature da un team della
University of California a Berkeley, spiega che i tibetani devono questa resistenza ad un
allele (variante genica) ereditata dai denisoviani almeno 40 mila anni fa (periodo in cui si ritiene si siano estinti).
Questa variante ha permesso loro di sopravvivere ai bassi livelli di ossigeno presenti a 4500 metri senza per questo soffrire delle problematiche cardiovascolari (tra cui il sangue denso) attese. Una conferma, secondo gli autori dell'articolo, "che il processo adattivo ha sfruttato i geni di un'altra specie".
Il gene chiave, chiamato
EPAS1, si attiva quando il livello di ossigeno ematico scende, ed è l'interruttore che da il via alla catena di eventi che porta all'aumento dei livelli di emoglobina. Non a caso alcune varianti di questo gene sono state ribattezzate come il "
gene del superatleta" in quanto a basse altitudini rende l'atleta capace di trasportare molto più ossigeno nel sangue, aumentando la resistenza alla fatica muscolare. Queste varianti "comuni" nella popolazione generale non sono però particolarmente utili ad alta quota se non nel breve periodo proprio perché aumentano il numero di globuli rossi e quindi la viscosità ematica.
La variante presente nei tibetani è diversa nel senso che è meno responsiva alla minore pressione di ossigeno; vale a dire che il livello di emoglobina aumenta si ma meno di quanto avviene con la forma classica del gene. L'incremento è sufficiente per ossigenare il sangue ma non tale da provocare gli effetti indesiderati sopra descritti.
L'adattamento genetico a vivere in alta quota presenta alcuni tratti comuni alle diverse popolazioni e altri specifici per ciascuna. Caratteristica comune è l'aumento del volume polmonare che si evidenzia dall'esterno con una più ampia gabbia toracica. Un incremento del volume polmonare si associa ad un aumento della superficie alveolare e quindi una più efficiente ossigenazione del sangue.
Riguardo ai tratti specifici questi variano a seconda della popolazione in esame. Le popolazioni andine hanno un maggior numero (per unità di volume) di globuli rossi e di emoglobina, grazie alle quali aumenta la capacità di trasporto di ossigeno. Si tratta di un adattamento reversibile perché in caso di permanenza a bassa quota per qualche settimana, i valori diventano simili a quelli degli abitanti di bassa quota. Se analizziamo invece i tibetani, oltre a quanto letto nei paragrafi precedenti, l'adattamento è di tipo respiratorio con respiri profondi e veloci a cui si aggiunge un maggior diametro dei vasi sanguigni. In questo caso si tratta di una modifica permanente che non varia anche in seguito al cambio di residenza. Gli etiopi degli altopiani non presentano invece alcuno dei precedenti adattamenti ma hanno una variante polimorfica del gene codificante per il recettore di tipo B della endotelina, che conferisce maggiore resistenza cardiaca alla carenza di ossigeno.
Ebbene, questa rarissima variante genetica (di fatto presente solo nei tibetani) è presente nel DNA denisoviano. Nemmeno gli Han, l'etnia cinese più comune che per ragioni geografiche dovrebbe essere più affine ai tibetani, ha questo allele. Il fatto che i tibetani abbiano pochissimo DNA denisoviano rispetto ai melanesiani (lo 0,1% contro il 5%) è un'altra indicazione del vantaggio selettivo centrato sull'allele EPAS1.
Lo scenario evolutivo-migratorio più probabile ad oggi vede i sapiens provenienti dall'Africa incrociarsi prima con i neanderthal (e da qui l'origine di tutte le popolazioni non africane) e poi, nella marcia verso oriente, l'incontro con i denisoviani. Ci sarebbe stata a questo punto una separazione tra coloro che colonizzarono il Tibet e tutti gli altri che invece avrebbe continuato a vivere a bassa quota. Nel primo caso la variante genica sarebbe stata conservata proprio per il vantaggio selettivo associato, mentre negli altri orientali questo allele si sarebbe "diluito" nel corso delle migliaia di generazioni successive in quanto né utile né dannosa (quindi non selezionata).
Non è chiaro ad oggi se le popolazioni ad oggi più simili ai denisoviani (i
negritos delle Filippine ad esempio) siano originate dallo stesso contatto che poi ha portato ai tibetani.
 |
| L'espansione umana e l'incontro con i "cugini" Homo ( credit: KR Veeramah & MF Hammer / Nature Reviews Genetics). Altra mappa utili alla comprensione QUI. |
E' oggi evidente che il percorso evolutivo della specie sapiens si è avvalso del contributo di altre specie del genere Homo oramai estinte, di cui nulla sapremo in assenza di miracolosi ritrovamenti fossili, sufficientemente conservati da poterne analizzare il DNA. La speranza è quella di imbatterci in reperti come quelli ritrovati in una grotta dell'Asia centrale (i reperti trovati in Sudafrica poche settimane fa sono molto interessanti ma anche ben anteriori alla comparsa dei sapiens -->
Homo maledi).
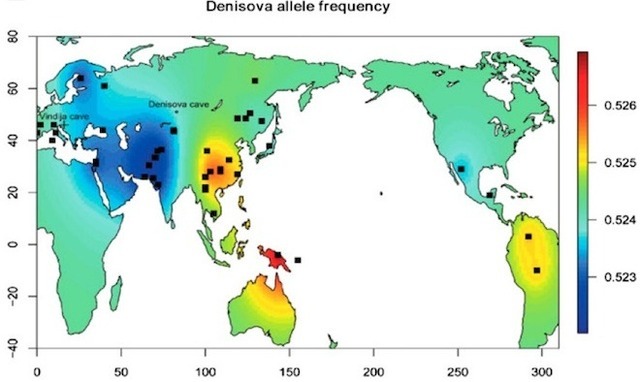 |
| Studi recenti (Current Biology e Science) ha permesso di aggiornare la mappa della frequenza degli alleli denisoviani. I dati hanno permesso anche di aggiornare il momento dell'incrocio tra sapiens e denisova (tra 44 e 54 mila anni fa) e del sapiens con neanderthal (50-60 mila anni fa) |
*** aggiornamento maggio 2019 ***
Un reperto osseo (la porzione inferiore di una mandibola) rinvenuto all'inizio degli anni '80 da un monaco tibetano in una grotta in località Baishiya Karst è stato ora ufficialmente catalogato come reperto denisovano il che lo pone come primo reperto della specie mai rinvenuto oltre a quelle della grotta Denisova (
--> Nature)
 |
| Credit: Dongju Zhang, Lanzhou University via Nature |
Altri articoli correlati su questo blog
sul tema "evoluzione recente genere Homo --> QUI
Sull'origine degli amerindi --> QUI
Sui temi di antropologia --> QUI
Fonte
- Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA
Emilia Huerta-Sánchez et al, (2014) Nature 512, 194–197
- The Combined Landscape of Denisovan and Neanderthal Ancestry in Present-Day Humans