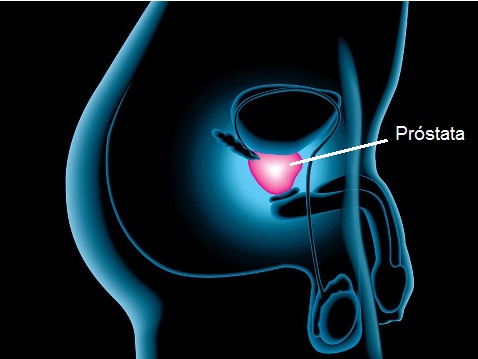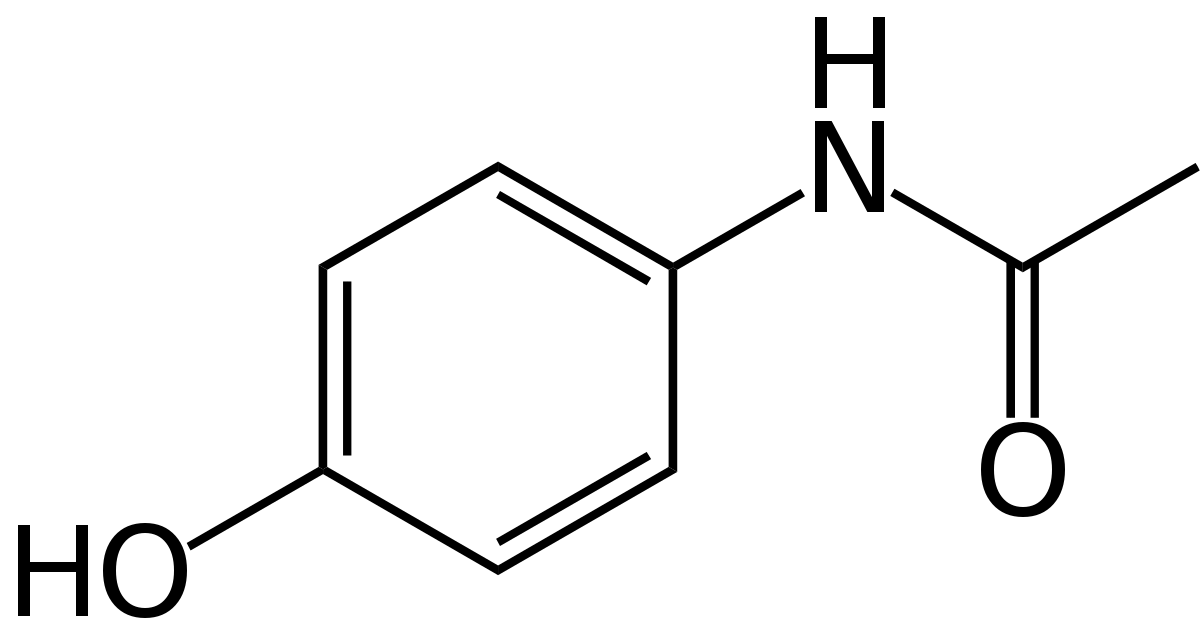A distanza di due anni dal picco dell'epidemia di Ebola cominciano ad arrivare i risultati dei primi studi clinici sull'efficacia dei trattamenti terapeutici iniziati in quel convulso periodo.
A distanza di due anni dal picco dell'epidemia di Ebola cominciano ad arrivare i risultati dei primi studi clinici sull'efficacia dei trattamenti terapeutici iniziati in quel convulso periodo.Precedente articolo sull'argomento --> "L'epidemia di Ebola ad un anno dal suo inizio"Uno degli approcci di cui molti parlarono all'epoca era centrato sull'utilizzo del siero prelevato ai soggetti in convalescenza, guariti più o meno spontaneamente (vedremo poi il senso di questo avverbio). Dal siero ottenuto sarebbe stato poi "facile" estrarre, o anche solo concentrare, gli anticorpi che avevano vinto la sfida contro il virus, per iniettarli nei malati in cui tale risposta non era ancora maturata.
Nota. In assenza di farmaci specifici per il virus, il trattamento dei pazienti era principalmente sintomatico, volto cioè a sostenere l'organismo fintanto che fosse stato in grado di maturare una risposta immunitaria efficace; tra questi, la reidratazione del malato giocò un ruolo chiave per aumentare la probabilità di sopravvivenza. Dato il decorso rapido (fatale nel 90 per cento dei casi entro le tre settimane dall'insorgere dei sintomi) il vero vulnus dei malati era la mancanza di tempo per montare una risposta anticorpale contro un patogeno mai incontrato prima (necessarie circa 3 settimane). I vaccini funzionano proprio su questo principio, cioè fornendo all'organismo versioni innocue (o meno virulente) del patogeno in modo che gli antigeni ad esso associati siano catturati dalle cellule sentinella e usati per istruire i linfociti a montare una risposta specifica contro quel dato patogeno. Una volta cessata l'esposizione acuta all'antigene, i linfociti "addestrati" rimarranno in circolazione a formare una memoria immunitaria (da cui il nome di linfociti B e T di memoria); qualora l'organismo dovesse rincontrare anche a distanza di anni un patogeno contenente antigeni "noti", le cellule di memoria monteranno una risposta efficace nel giro di soli 3 giorni. Tanto meno variabile il patogeno e tanto più efficace l'azione preventiva del vaccino. Come avvenne all'epoca delle epidemie di peste (che uccise il 30% della popolazione europea) solo pochi tra gli individui infettati ebbero la "fortuna" di contrarre una infezione a cui riuscirono a sopravvivere. I motivi di questa "fortuna" sono vari e vanno dall'essere stati infettati da un virus "debole" a caratteristiche genetiche individuali che rendono difficile al virus replicarsi nelle cellule di quel dato soggetto; il risultato netto è che il paziente "resiste" il tempo sufficiente perché il sistema immunitario (una macchina ineguagliabile per capacità di adattamento) riesca a sconfiggere l'intruso.
Cosa ci dice la "biologia" dei sopravvissuti? Per motivi poco compresi il loro sistema immunitario è in grado di produrre linfociti CD8+ diretti contro le cellule infettate (risposta citotossica) e al contempo minimizzano la produzione di molecole immunosoppressive (un meccanismo necessario in condizioni standard per evitare reazioni infiammatorie eccessive). Fonte: Nature.Tornando alle speranze legate alla trasfusione di plasma come "facile" modalità terapeutica (pratica nota come immunizzazione passiva), c'è da sottolineare che l'illusione di avere a disposizione un facile strumento terapeutico era figlia, oltre che dalla assenza di alternative nel breve termine, di una certa confusione tra realtà e finzione cinematografica; una confusione alimentata, come sempre, dai media impreparati o semplicemente non interessati a trattare la scienza in modo ... scientifico. Molti sono i film che hanno alimentato questa visione semplicistica; tra i tanti cito "Virus Letale", emblematico per la presenza di un fantavirologo (interpretato da Dustin Hoffman) del molto reale Center for Disease Control (CDC) che riusciva a curare centinaia se non migliaia di soggetti partendo dal plasma di un singolo paziente sopravvissuto (e tutto in questo nel giro di pochi giorni, nemmeno il paziente avesse ettolitri di sangue da donare ...).
Nella realtà, il procedimento, sebbene sensato scientificamente, è anche pieno di punti interrogativi legati sia alla ipotizzata omogeneità genetica della popolazione virale nel bacino epidemico (cosa non proprio ovvia se non di fatto falsa come nel caso del variabilissimo virus dell'influenza) che per il rischio di innescare una reazione autoimmune nei soggetti trattati, a causa del riconoscere come estranei gli anticorpi iniettati.
Nota. Il trattamento basato sulla trasfusione del plasma è stato usato con un certo successo agli inizi del XX secolo per trattare pazienti con parotite, difterite o morbillo, patogeni caratterizzati (non a caso) dall'avere un tasso di variabilità (alias mutazioni) molto basso. L'approccio cadde poi in disgrazia con l'avvento dei farmaci antibiotici o antivirali, nettamente più efficaci ... quando il patogeno è sensibile. Se non ricordo male l'approccio basato sul plasma è ancora oggi in uso per la febbre emorragica argentina.
Donare il sangue è meritorio. Ancora di più se chi lo dona è
un sopravvissuto che porta "in dote" gli anticorpi contro Ebola
(image: news.liverpool.ac.uk)
Arriviamo così al punto saliente, cioè i risultati del primo studio clinico basato sull'utilizzo del plasma sanguigno donato dai sopravvissuti in fase di convalescenza (quando il titolo anticorpale è ancora alto) ai pazienti ancora in lotta. La scelta di usare il plasma invece degli anticorpi purificati dipese da problemi logistici e di "corsa contro il tempo".
Lo studio, condotto da un consorzio internazionale di ricercatori, ha utilizzato il plasma donato dai sopravvissuti di Ebola per darlo a 84 pazienti ricoverati al centro di trattamento gestito da Medici Senza Frontiere sito a Conakry, capitale della Guinea. Ciascun paziente ha ricevuto circa mezzo litro di plasma, diviso in due dosi.
I risultati non sono stati positivi, mancando di ottenere una riduzione statisticamente
significativa del rischio di morte rispetto a coloro che avevano
ricevuto il miglior trattamento standard (volto a mantenere l'idratazione). Il tasso di mortalità del 31% nel gruppo trattato con il plasma è poco diverso
dal tasso di mortalità del 37,8% misurato nel gruppo di controllo di 418
persone ricoverati nel centro 5 mesi
prima dell'inizio della sperimentazione. Dopo avere corretto i dati grezzi tenendo conto di variabili come età e carica virale, la differenza tra i due gruppi è circa del 2,6% e non
è statisticamente significativa. Sebbene alcuni dati fossero in controtendenza, cioè la straordinaria percentuale di sopravvivenza dei neonati trattati (4 su 5), i numeri sono statisticamente inaffidabili rispetto ai 1523 neonati del gruppo di controllo.
In altre parole, non vi è alcun indizio reale che tale trattamento sia minimamente efficace.
I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista medica New England Journal of Medicine.
Il futuro.
Per completare lo studio di efficacia di questo approccio, potrebbe essere necessario selezionare, tra i pazienti sopravvissuti e desiderosi di donare il plasma, solo quelli con alto titolo anticorpale e/o somministrare plasma "concentrato".
Nota. L'epidemia di Ebola è ora giunta al termine. Se non ci saranno nuovi casi segnalati alle autorità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarerà l'Africa occidentale libera da Ebola entro la primavera. Bene ricordare però che la Liberia ha visto nell'ultimo anno la comparsa di nuovi casi sporadici dopo una prolungata assenza di nuovi casi (un dato che ci ricorda che la minaccia del virus è sempre attuale e difficilmente debellabile in assenza di un vaccino). Per una cronistoria dell'infezione vedi --> QUI.
Articolo successivo sul tema --> "Il virus può permanere nel fluido seminale dei soggetti clinicamente guariti".
Fonte
-Evaluation of Convalescent Plasma for Ebola Virus Disease in Guinea
et al. N. Engl. J. Med. 374, 33–42 (2016)
- Ebola outbreak in West Africa (2013-2016)
European Centre for Disease Prevention and Control
- Ebola virus disease outbreak
World Health Organization (WHO)
European Centre for Disease Prevention and Control
- Ebola virus disease outbreak
World Health Organization (WHO)