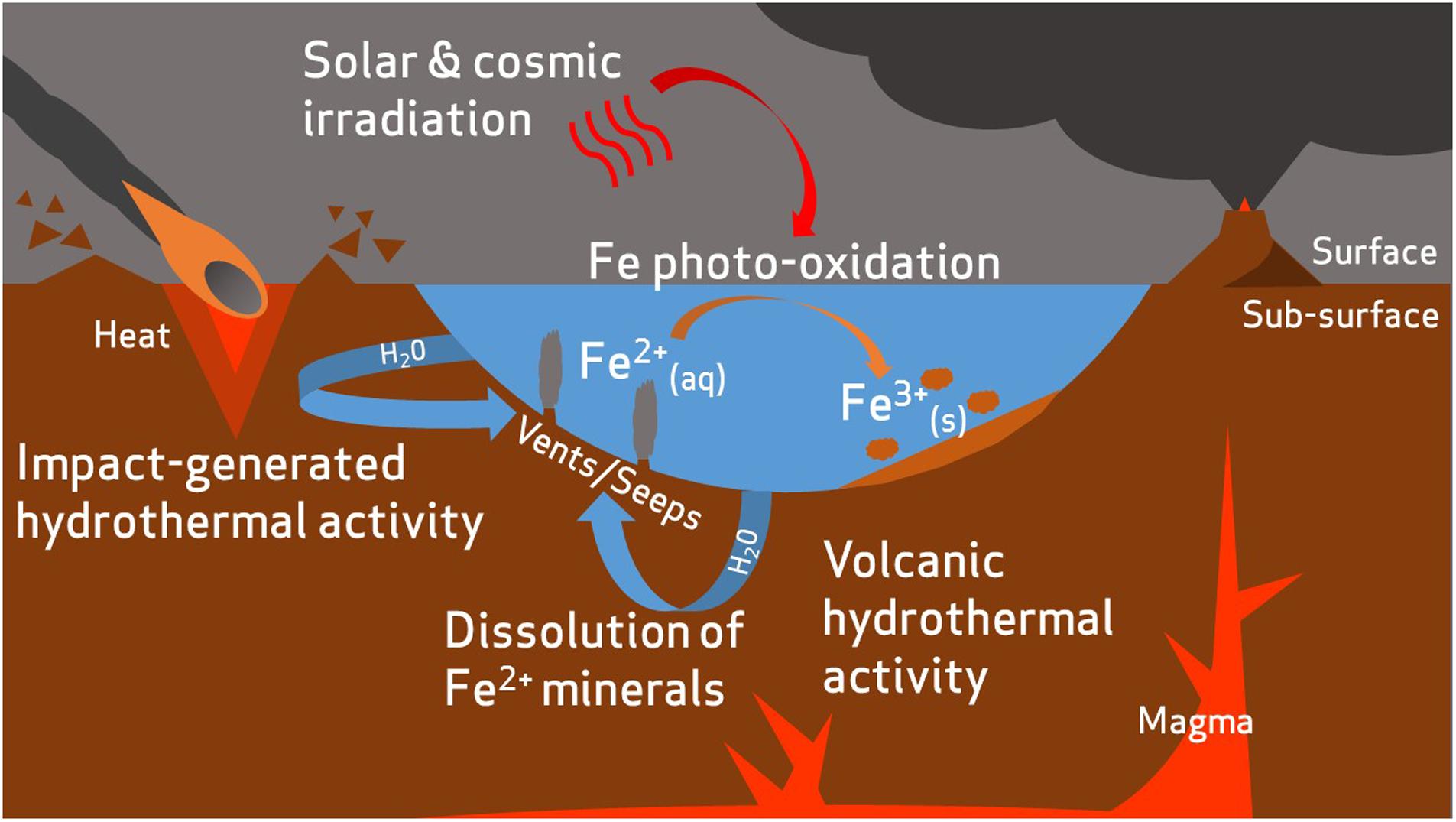Sebbene sia ancora prematuro trarre conclusioni, alcuni indizi sembrano indicare l’esistenza di un collegamento tra il rischio malattie autoimmuni e il virus che causa COVID-19. Un problema molto importante da considerare ora che (forse) siamo usciti dalla fase acuta della pandemia e ci affacciamo incerti in una nuova fase endemica, meno aggressiva, ma da monitorare.
Ricordo per inciso che anche se il peggio sembra essere alle spalle, rimane il punto interrogativo sugli effetti a lungo termine in chi si è infettato e, pur essendo guarito, manifesta una serie di disturbi che vanno sotto il nome di Long Covid syndrome. Tra i sintomi principali stanchezza persistente, difficoltà di concentrazione e mancanza di respiro. Interessante notare che tali sintomi hanno una forte somiglianza con l'encefalomielite mialgica (ME), nota anche come sindrome da stanchezza cronica (patologia ad eziologia ignota). Uno studio su PNAS del 2021 ha suggerito che in entrambe le malattie i sintomi potrebbero essere la conseguenza di autoanticorpi.
Alle incertezze sul Long Covid, si aggiunge la presenza, in un numero basso ma non trascurabile di individui, di sintomi riconducibili alle patologie autoimmuni, come infiammazione dei vasi sanguigni, eruzioni cutanee e danni agli organi. Alcuni di questi pazienti sviluppano malattie autoimmuni conclamate, come il diabete di tipo 1, il LES o l'artrite psoriasica.
 |
| Image credit: L. Calabrese et al, (2021) An. Rheum. Disease |
Partiamo da un concetto base cioè cosa significa autoimmunità.
È un fenomeno clinico che si innesca quando il sistema immunitario attacca i tessuti sani in modo "voluto" e non come effetto collaterale dello stato infiammatorio. Si tratta di vero e proprio fuoco amico con l'aggravante che il sistema è "convinto" che il bersaglio individuato sia veramente il nemico.
 |
| Image credit: niehs.nih.gov |
Le cause sono varie e risiedono sia nella predisposizione genetica (ad esempio avere particolari alleli del gene MHC-II) che nel comportamento di alcuni patogeni (spesso virus) che dopo essersi accasati in un tessuto richiamano l'attenzione delle pattuglie immunitarie la cui risposta può andare "fuori bersaglio" per varie ragioni: la somiglianza strutturale di alcune porzioni virali con quelle dell’ospite; la lisi cellulare che libera (e rende disponibili alle cellule spazzino che poi recluteranno i linfociti adatti) antigeni intracellulari “legittimi” che non vengono riconosciuti come tali dal sistema (complice la presenza di linfociti autoreattivi che avrebbero dovuto essere distrutti alla nascita).
Alcuni studi mediante modellistica al computer hanno evidenziato la somiglianza strutturale di alcune parti del virus con quelle dello streptococco (da qui il dato che il vaccino contro lo streptococco pare fornire una certa protezione dal virus). Ciò potrebbe innescare una risposta potente da parte del sistema innato che riconosce (per errore) un nemico di vecchia data.Altri studi hanno evidenziato la somiglianza di altre parti del virus con porzioni di proteine umane, come i fattori della coagulazione. In alcune persone (vuoi per la genetica vuoi per motivi ancora poco noti), il sistema immunitario risponde dando la caccia a dei fantasmi sulla base di una foto segnaletica che somiglia pericolosamente a proteine self. Tra le conseguenze la comparsa di sintomi riferibili a coaguli di sangue e a cascata danni multiorgano.
Tra le malattie autoimmuni più comuni abbiamo il diabete di tipo 1, l'artrite reumatoide, la sclerosi multipla e LSE (lupus eritematoso sistemico) che si differenzia dalle precedenti perché il sistema immunitario attacca più di un tessuto. Le terapie in sviluppo (e quelle futuribili) anelano a “rieducare” il sistema immunitario, attivando i meccanismi regolatori che solitamente disattivano l’attacco linfocitario prima che faccia danni ai tessuti normali (leggasi contenere l’infiammazione una volta iniziata e, prima ancora, eradicare ogni tipo di linfocita che sia autoreattivo).
Nota. Uno studio del 2019 su pazienti con diabete di tipo 1 ha rilevato la presenza di alcuni virus gastrointestinali che potrebbero avere innescato la risposta autoimmune. Studi simili hanno suggerito il coinvolgimento del virus di Epstein-Barr nella comparsa (in soggetti geneticamente predisposti) della sclerosi multipla e del lupus.
Fatta la premessa, torniamo al Covid19.
In modo quasi paradossale la recente pandemia potrebbe perfino aiutare lo sviluppo di terapie contro le patologie autoimmuni grazie a quanto appreso sui sintomi prima menzionati rilevati in alcuni pazienti.
Per capire come, è necessario considerare la prima linea di difesa (barriere fisiche escluse) contro i patogeni intracellulari (in primis i virus), parte della cosiddetta immunità innata. L'interferone gioca un ruolo di primo piano in questo ambito, grazie al suo essere sia un regolatore di specifici geni (e a valle di pathways di regolazione) che come segnale di allarme ad altre cellule.
Una volta che specifici complessi proteici intracellulari rilevano la presenza di entità di natura chiaramente "aliena" (molecole di RNA a doppio filamento, etc) si attiva la risposta che porta in ultima istanza alla produzione di vari tipi di interferone, che fungeranno da segnale di allarme alle cellule vicine mentre nel contempo la cellula colpita attiverà il processo di autodistruzione così da eliminare anche il virus al suo interno.
Come si suol dire "fatta la legge, trovato l'inganno" ecco che i virus hanno evoluto delle contromisure per almeno ritardare il lancio del segnale d'allarme. Tra questi abbiamo il SARS-CoV-2 che mediante le proteine NSP1 e NSP13 spegne l'allarme bloccando l'attivazione dell'interferone. Questo meccanismo è stato osservato nei pazienti con forma grave della malattia, il che pare indicare che nella maggior parte dei soggetti a decorso non grave, si siano attivati dei meccanismi alternativi di rilevamento e contenimento virale.
Mentre questo trucchetto implementato dal virus è noto dai primi mesi della pandemia, più recente è l'osservazione della presenza (sempre nei pazienti gravi) di anticorpi diretti contro l’interferone, il che spegne del tutto il sistema d'allarme. In quest'ultimo caso si tratta di una risposta anomala dell'organismo che produce anticorpi che non dovrebbe produrre.
Nota. Gli anticorpi "spontanei" contro l’interferone sono noti fin dagli anni ’80 quando furono rilevati in un paziente oncologico trattato con gli interferoni. Negli stessi anni furono scoperti anche in un paziente con lupus (qui sembra che parte degli effetti dannosi fossero dovuti al complesso anticorpo-interferone, rispetto all'attesa azione neutralizzante la risposta immunitaria dell'anticorpo).
Poiché gli anticorpi appartengono alla risposta immunitaria adattativa, che necessita di almeno 2 settimane per diventare efficace, un tale fenomeno può essersi sviluppato solo nei soggetti rimasti infetti per un periodo prolungato di tempo (in genere le persone nelle ICU).
Non c'è una spiegazione semplice sul perché questi anticorpi siano stati prodotti (e selezionati); verosimilmente si tratta di una somma di ragioni genetiche e ambientali tra cui la cattura di molecole sul luogo dell’infezione da parte delle cellule spazzino, che poi trovano nella "nursery" dei linfociti (midollo osseo) una controparte linfocitaria che avrebbe dovuto essere stata eliminata (tutti i linfociti potenzialmente reattivi contro molecole self vengono eliminati nelle fase iniziali del loro differenziamento).
La domanda che ora vi sorgerà spontanea è dove sia l'aiuto che questi "effetti collaterali" del Covid19, potrebbe fornire allo sviluppo di nuove terapie contro le patologie autoimmuni.
Il tutto si basa sul fatto che in alcuni pazienti il sistema difesa basato sull'interferone agisce come una lama a doppio taglio, nel senso che o smette di funzionare (il virus si diffonde) oppure funziona troppo (con rischio di malattie autoimmuni).
Varie sono le informazioni che si possono ricavare da questi pazienti.
- Comprendere il legame tra la molecola virale che assomiglia a strutture self, permetterà di disegnare terapie per colpire in modo preciso i linfociti autoreattivi (ad esempio mediante anticorpi monoclonali).
- I soggetti in cui si è rilevata la presenza di anticorpi anti-interferone potrebbero ugualmente essere i destinatari di terapie mirate alla eliminazione delle cellule produttrici degli anticorpi indesiderati. Nello stesso tempo questi pazienti permettono di comprendere cosa ha portato alla produzione di anticorpi non desiderati
- Gli anticorpi anti-interferone potrebbero diventare un utile strumento terapeutico per spegnere l'eccesso di attività immunitaria auto-diretta. A riprova dell'utilità di tale approccio, uno studio del 2021 in cui si utilizzano anticorpi monoclonali anti-interferone nel trattamento delle patologie reumatiche autoimmuni. Un esempio è il loro utilizzo nei pazienti con LES.
Dall'analisi di tutti questi punti si potrà avere una maggiore comprensione delle dinamiche alla base dell'eccesso di attività immunitaria e di come prevenire (prima che compaiano i sintomi) patologie dovute a tale eccesso (o errato bersaglio).