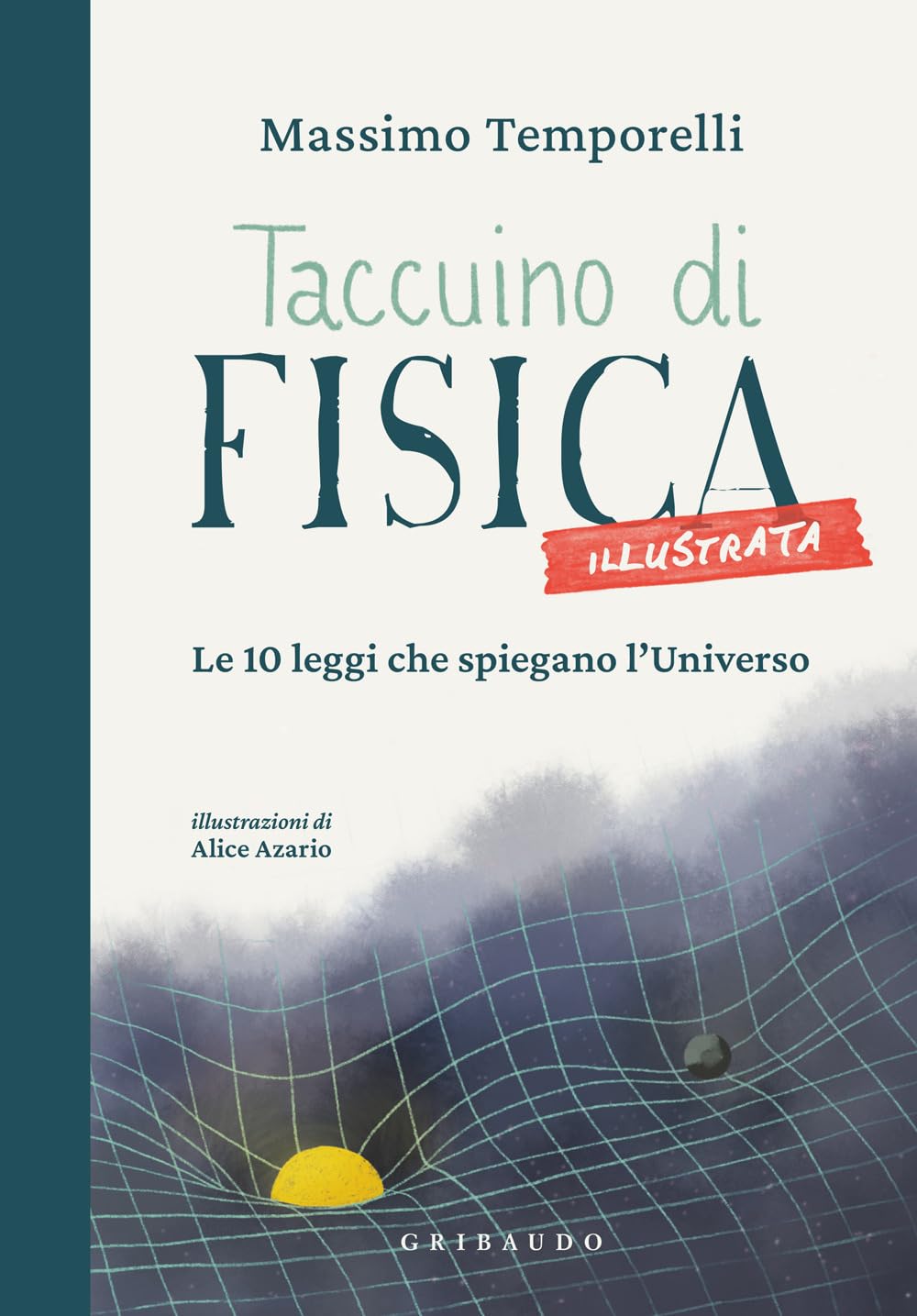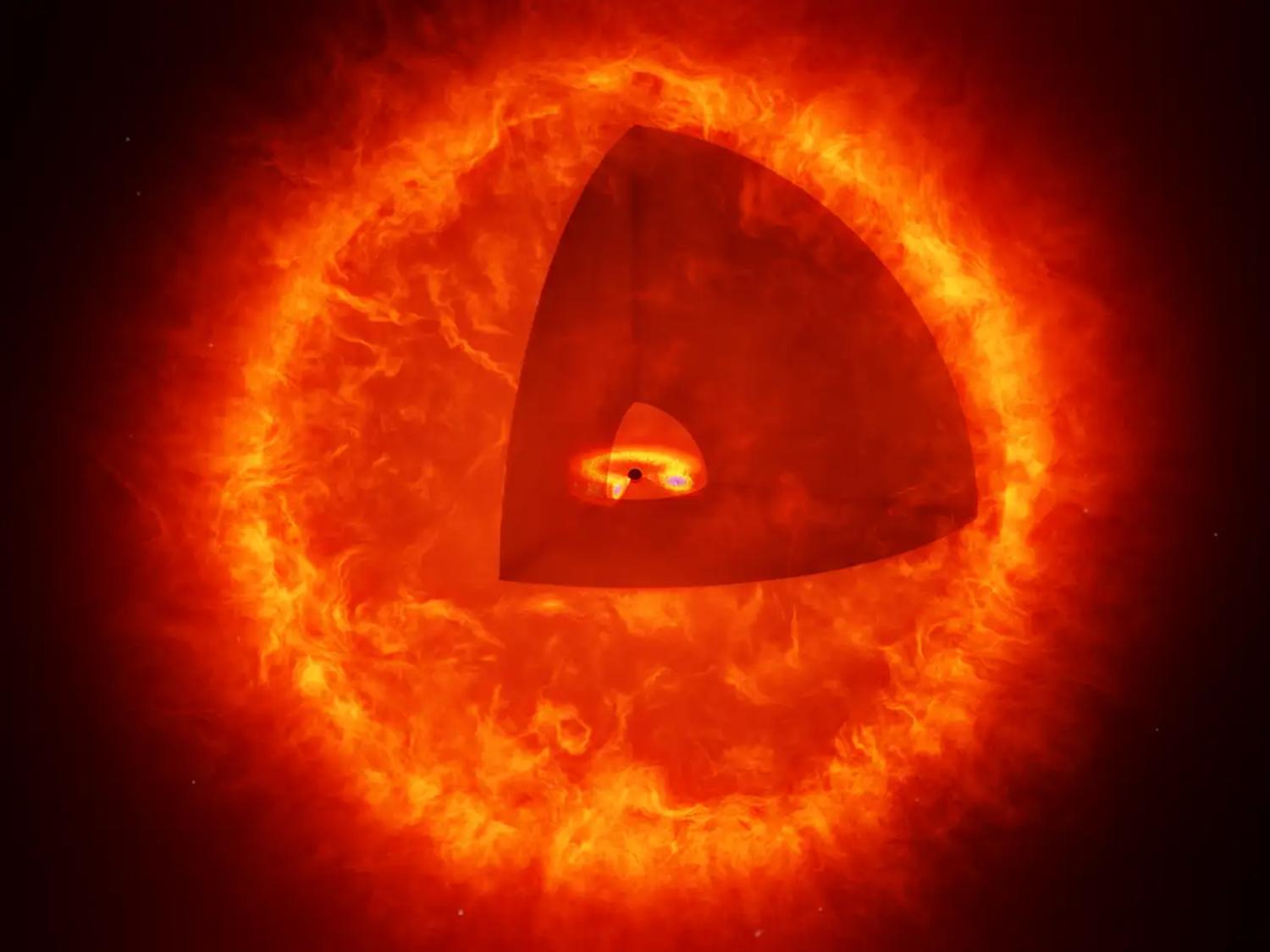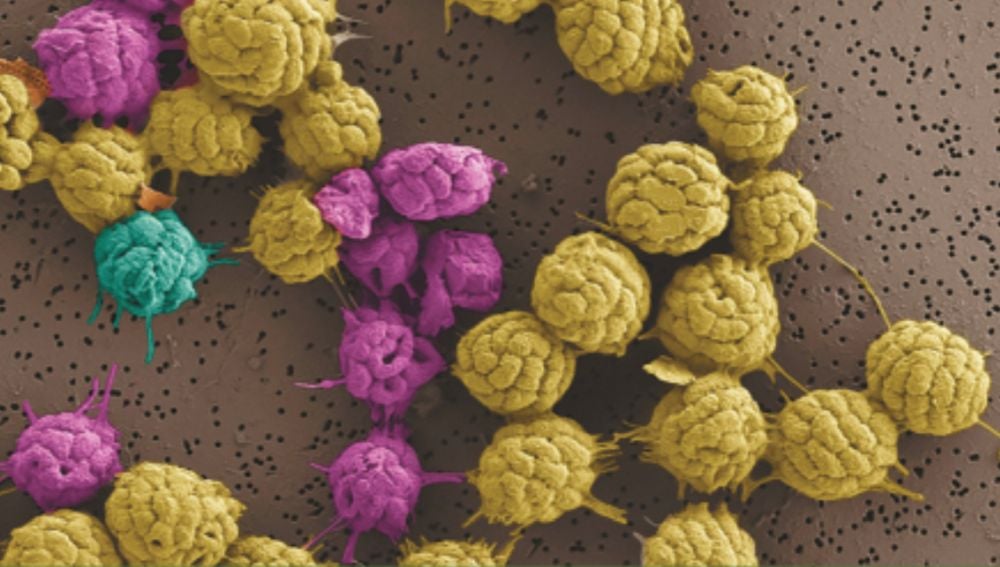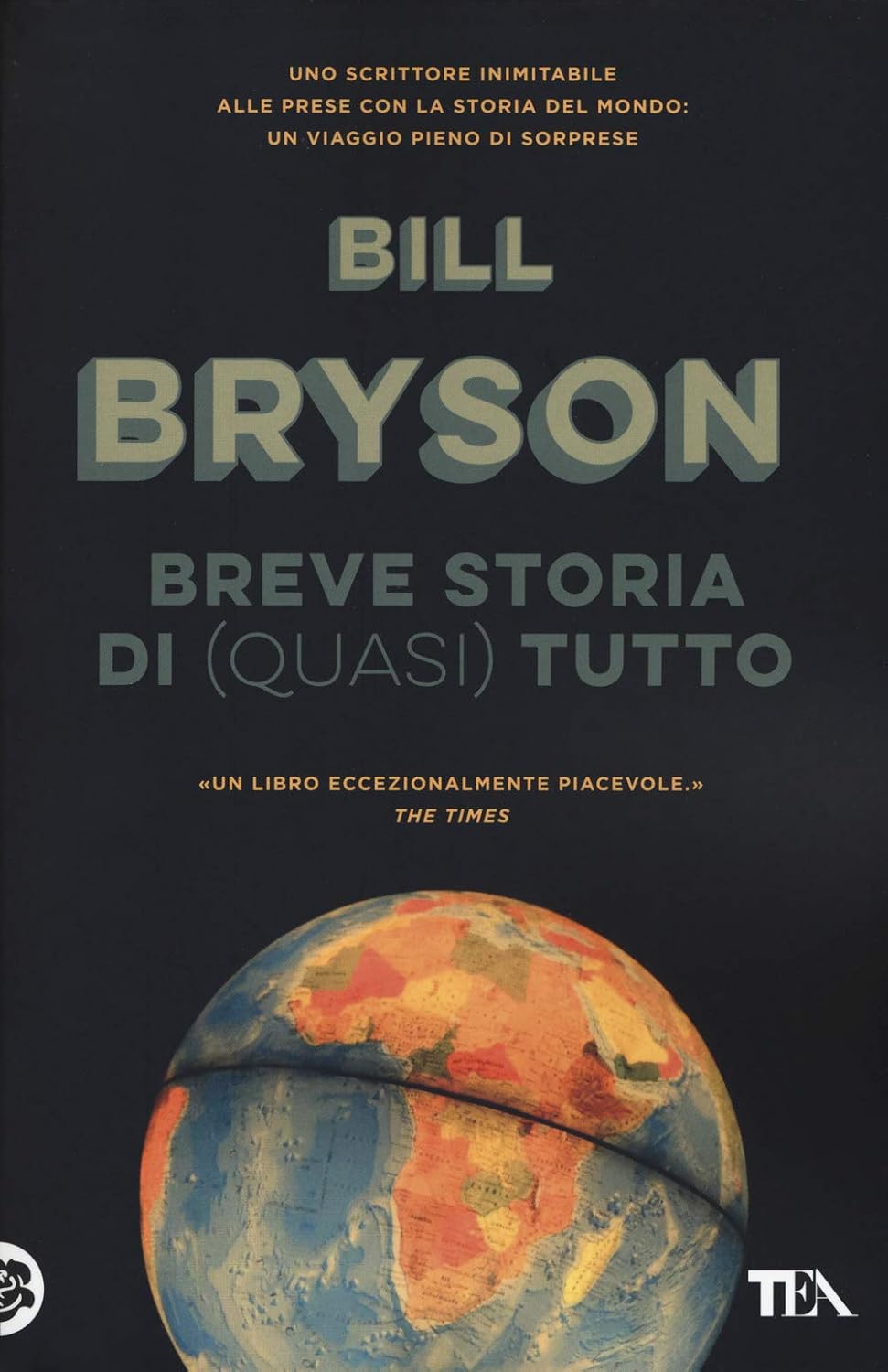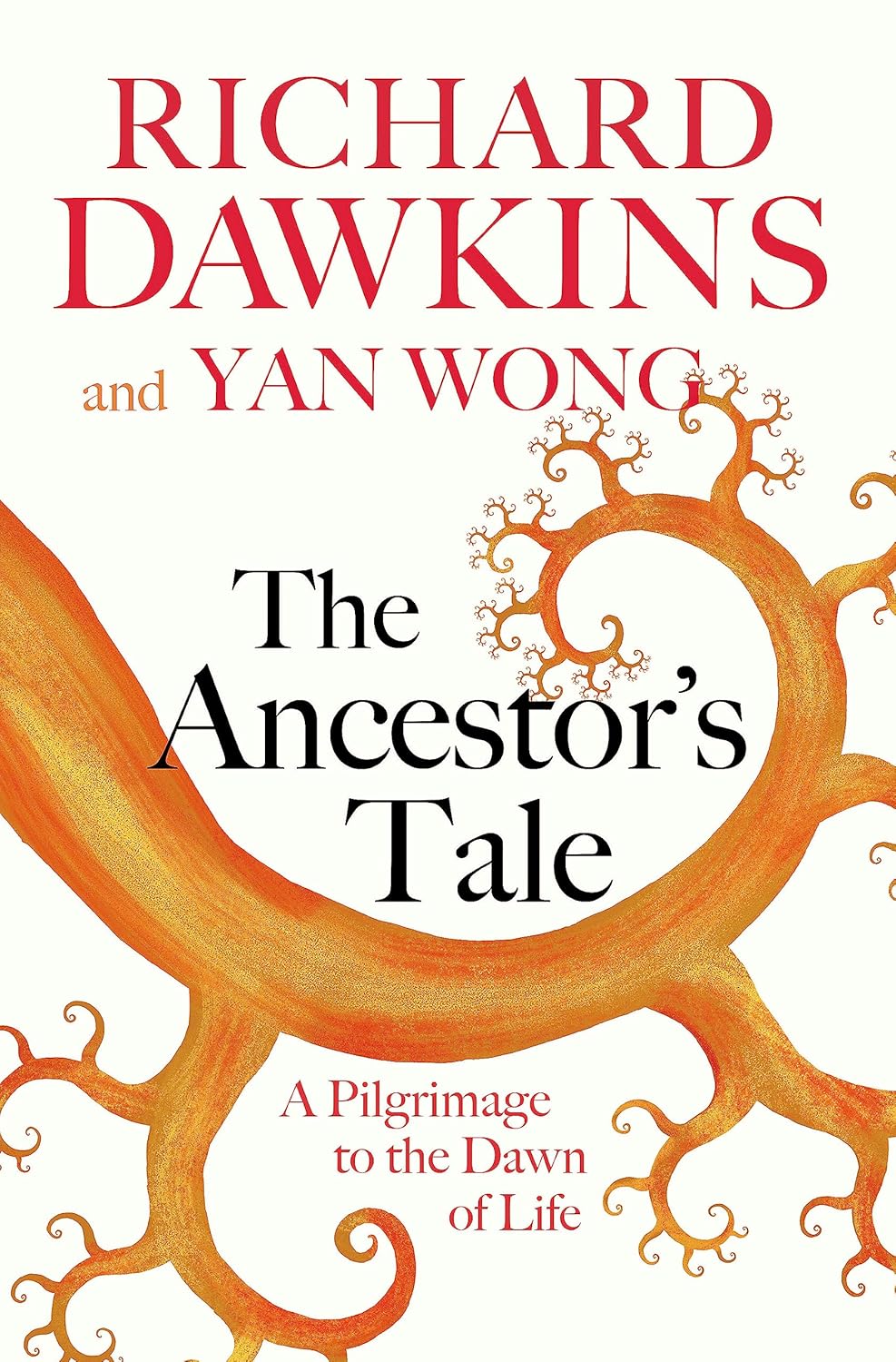Ogni anno torniamo agli articoli vincitori degli Ig-Nobel in quanto sempre interessanti. Del resto il premio, nato decenni fa all'università di Harvard, nasce proprio per segnalare una ricerca che "prima fa ridere, poi fa riflettere".
Se ridere e poi riflettere è il tratto distintivo, quest'anno i partecipanti alla premiazione proveranno anche un certo languorino dato tra le ricerche premiate (categoria "Fisica") c'è quella sul come preparare la salsa perfetta per fare la pasta cacio e pepe, piatto romano per eccellenza.
I ricercatori, tutti italiani sebbene afferenti a diversi istituti di ricerca in Europa, coordinati da Fabrizio Olmeda, fisico presso l'Istituto di Scienza e Tecnologia Austriaco (ISTA), si sono cimentati in questo compito frustrati dalla variabilità nella riuscita del piatto ogni volta che vi si cimentavano. Di fronte alla variabilità non restava che usare il metodo scientifico per creare una ricetta (in laboratorio lo chiameremmo "protocollo") affidabile.
Il risultato è stato pubblicato sulla rivista Physics of Fluids.
Banalità? Non proprio. Preparare un sugo perfetto non significa solo mescolare i pochi ingredienti essenziali (pecorino, acqua di cottura della pasta, pepe), perché il risultato più comune sarà un sugo grumoso, simile alla mozzarella.
L'acqua di cottura della pasta (presente in ogni ricetta della cacio e pepe) serve a fornire l'amido importante per emulsionare e stabilizzare il sugo, ma da solo non è sufficiente. A temperature superiori a 65 gradi le proteine del formaggio si denaturano e si aggregano, causando la disgregazione del composto.
Per ottenere un sugo perfetto bisogna aggiungere all'acqua la giusta quantità di amido in polvere (2-3% del peso del formaggio) finché non diventa limpida e si addensa come un gel. A questo punto si mescola il gel con il formaggio a bassa temperatura in modo che l'amido si leghi alle proteine e prevenga la formazione di grumi. Il pepe viene aggiunto alla fine prima di mescolare la pasta con il sugo direttamente nella padella (nel caso si può aggiungere altra acqua di cottura per ottenere la giusta consistenza).
Ricapitolando ecco la ricetta "perfetta"
- 4 g di amido (di patate o di mais)
- 40 ml di acqua (per amalgamare l'amido)
- 160 g di Pecorino Romano
- 240 g di pasta (preferibilmente tonnarelli)
- Acqua di cottura della pasta
- Pepe nero e sale (a piacere)
Effetti collaterali di questo articolo? Avvicinare al metodo scientifico anche chi con esso non ha familiarità.
Tra gli altri vincitori meritano una menzione Tomoki Kojima (cat. Biologia) per aver dimostrato che dipingere le mucche con strisce bianche e nere può impeedire alle mosch di pungerle senza bisogno di pesticidi, o all'olandese per avere osservato che bere alcol, a volte ti permette di migliorare la capacità di parlare lingue straniere (lista completa QUI)
Fonte
- Phase behavior of Cacio e Pepe sauce
G. Bartolucci et al, Physics of Fluids 37, 044122 (2025)
***
Sul tema scienza e cucina non posso che consigliare gli ottimi volumi tematici di Dario Bressanini. Sempre nella mia libreria a portata di mano (link immagine ad Amazon)